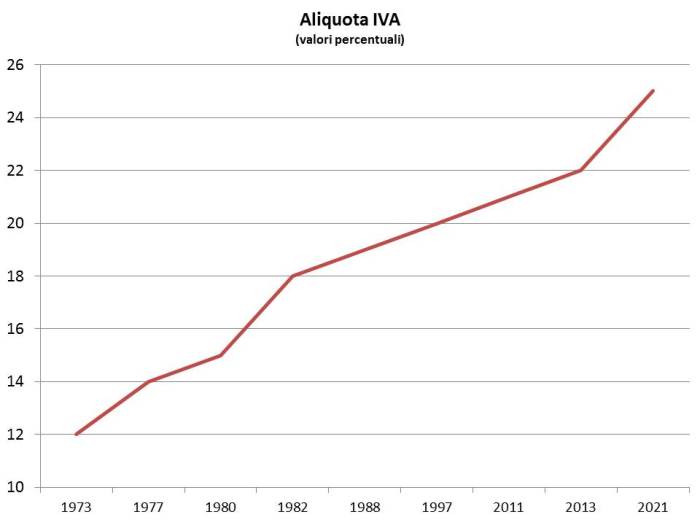Non esiste più una “questione ebraica”, quella di cui parlava Karl Marx, a metà degli anni Quaranta, del secolo XIX. Ed è riduttivo parlare oggi di una “questione palestinese”, alludendo a una situazione che va chiamata col suo nome: l’ultimo esempio di oppressione coloniale, praticata, al di fuori di ogni legalità, da un avamposto euro-americano in Medio Oriente. Ed è ora di dire, a gran voce, basta!
Basta al ricatto dell’antisemitismo, l’accusa sfoderata ad ogni occasione dagli israeliani e dalle loro infinite estensioni mondiali, a cominciare dalle Comunità ebraiche sono ormai compiuta espressione, megafoni dei governi di Israele. È ora di smentire la narrazione corrente che vede lo Stato nato ai danni dei palestinesi nel maggio 1948, come un riflesso della Shoah, ossia un risarcimento allo sterminio di milioni di ebrei da parte dei nazisti. È ora, piuttosto, di fare un ripasso di storia, invece che un bagno di lacrime, che possono essere false e capziose, come aveva accusato Norman Finkelstein rivolta ad una studentessa che si era messa a piagnucolare mentre lui denunciava la politica israeliana: lui, ebreo, con i familiari sterminati in un lager, sul quale, in modo scientifico, è ricaduta l’accusa di “ebreo antisemita”, appena ha cominciato a denunciare “l’industria dell’olocausto”.
Ebbene il ripasso di storia ci dice che il sionismo precede la Shoah, ci dice che il destino dei palestinesi fu deciso nel 1916-17, dalla Gran Bretagna, prima con gli accordi segreti con la Francia, detti di Sykes-Picott, quando le due potenze imperialistiche si spartirono l’intera regione mediorientale, prendendosi il Regno Unito, appunto, la Palestina, la Francia, per esempio, la Siria (donde l’attenzione che da Sarkozy a Hollande fino al bellimbusto Macron, dedicano a quella nazione, per tenerla sotto controllo). L’anno successivo, il terribile e grandioso 1917, vide la famosa Dichiarazione Balfour, dal nome del ministro degli Esteri di Sua Maestà Britannica, nella quale, anche sulla base della fortunata predicazione sionistica precedente, veniva riconosciuto il principio di una “jewish home” in Palestina: “un focolare ebraico”. Nella dichiarazione si alludeva comunque alla necessità di salvaguardare i diritti delle popolazioni arabe preesistenti. Quei diritti finirono invece immediatamente nel dimenticatoio grazie a Hitler, e alla “soluzione finale”. La persecuzione nazista ha trasformato un intero popolo in vittima sacrificale, e questo, nel complice silenzio del mondo, negli anni della guerra mondiale, ha prodotto l’agghiacciante esito di trasformare quelle vittime in carnefici.
Con troppa facilità le Nazioni Unite, Urss compresa, riconobbero nel 1948 lo Stato di Israele, dopo una campagna di terrore portata avanti da gruppi ebraici in Palestina, alcuni inquadrati nelle forze armate britanniche, compresa quella “Brigata ebraica” che da qualche tempo si ridesta il XXV Aprile, pretendendo di partecipare alle manifestazioni, millantando un proprio ruolo determinante nella guerra di liberazione. Una Brigata che fu poi tra i protagonisti di quel sistematico tentativo di “pulizia etnica” ai danni dei palestinesi, come ha documentato, inoppugnabilmente, un altro intellettuale ebreo, israeliano, Ilan Pappe, costretto poi a lasciare la sua università (Haifa) e a trasferirsi in Gran Bretagna, dopo che intorno a lui – “ebreo antisemita”, naturalmente – si era fatta terra bruciata.
Da allora, da quel maggio 1948, Israele ha compiuto una costante politica di allargamento dei propri confini semplicemente con la forza del proprio esercito, e con l’aiuto decisivo degli Usa, sia delle amministrazioni sia delle lobbies ebraiche, determinanti nelle campagne elettorali statunitensi, in specie in quelle presidenziali. Davanti a loro, un mondo arabo frantumato, disorganizzato, con mezzi militari modesti e male gestiti, al quale peraltro della causa del popolo palestinese poco o nulla importa.
Alla fine lo spazio territoriale odierno israeliano è il doppio di quello di settant’anni or sono. Uno spazio acquisito illegalmente, dopo la prima acquisizione ottenuta con la violenza. Ma non è bastato. Mentre si facevano entrare ebrei di ogni parte del mondo, secondo un inquietante criterio etnico-religioso, per cercare di rafforzare una popolazione dai modesti tassi di natalità, si procedeva agli insediamenti di molti di costoro nelle zone, sempre più esigue, concesse ai palestinesi, che a un ceto punto furono violentate dalla costruzione del muro della vergogna, altra azione (e opera) illegale, ma tollerata dalle Nazioni Unite che pure ne hanno “deplorato” l’edificazione. Le oltre 70 risoluzioni dell’Onu contro atti dei governi israeliani non hanno sortito alcun effetto, e i governanti di Tel Aviv non si prendono neppure la briga di replicare ormai, giudicando, non a torto, quello delle Nazioni Unite, un rituale privo di valore.
La stessa politica messa in atto davanti alle condanne che sono seguite regolarmente agli attacchi micidiali, con bombardamenti a tappeto, perlopiù missilistici, contro Gaza, divenuta ormai, da tempo, un gigantesco campo di concentramento o come è stata definita “la più grande prigione a cielo aperto del mondo”. Nei territori palestinesi, come in Libano e in altri paesi limitrofi, esistono i “campi” del resto, dove sono stati rinchiusi i palestinesi della diaspora, che vivono in condizioni quasi sempre disumane, vivono in una situazione di “morte lenta”, come documentò in un suo reportage Edward Said. Proprio questo grande intellettuale palestinese-americano parlò anni fa del “vicolo cieco di Israele”, condannatasi per la propria protervia a combattere una guerra incessante, nel vano tentativo di sottomettere, soggiogare i popoli confinanti, condannata a dominare, nell’esacerbato timore di essere dominata, probabilmente dal fattore biologico, la natalità araba.
L’operazione “Margine protettivo” dell’estate 2014 è già quasi dimenticata, ma non dagli abitanti di Gaza, che hanno pagato un prezzo altissimo, in termini di vite, di sofferenza, di distruzione. Quali conseguenze ebbe quell’efferata azione durata tre settimane ai danni di Gaza? Nessuna. Israele si sta occupando della “ricostruzione”, arrivando, col massimo del cinismo, a lucrare anche sulle morti e sulle devastazioni da essa procurate.
E ora da settimane la protesta palestinese nella marcia del ritorno, che è culminata, dopo uno stillicidio di morti e di mutilati tra i giovani e giovanissimi (per ammissione di un generale israeliano i cecchini hanno l’ordine di sparare alle gambe, per far sì che i ragazzi perdano la possibilità di esser offensivi, e sono decine ormai coloro che hanno perso uno o entrambi gli arti inferiori), siamo giunti all’Armageddon: Trump e famiglia si recano a Gerusalemme, per sancire in una giornata dichiarata di festa, il trasferimento dell’ambasciata da Tel Aviv, mentre l’esercito “più morale del mondo” spara ad alzo zero: donne ragazzi bambini, vecchi; gente pacifica e militanti che gridano il loro diritto al ritorno. Fotografi e giornalisti, anche occidentali, sono stati colpiti. La fondazione di Israele non poteva trovare migliore sanzione. Uno Stato nato dalla violenza estrema, si autocelebra con la medesima violenza, moltiplicata; e due carnefici, Trump e Netanhyahu gongolano.
Il trasferimento dell’Ambasciata è un atto illegale che accetta e santifica un altro atto illegale: la dichiarazione di Gerusalemme “capitale unica eterna e indivisibile di Israele”. E il mondo cristiano si lascia scippare così una città sacra? E tutti i paesi arabi e islamici, a loro volta? Gli ebrei israeliani dettano legge, con l’orso americano alle spalle, e tutti piegano la testa. Ma chiediamoci se si possa ancora tollerare tutto questo.
Si può tollerare quello che sta accadendo? Si può tollerare che uno degli eserciti più potenti del mondo compia, indisturbato, un terribile massacro di gente inerme o armata forse di fionde e copertoni incendiati? Si può tollerare che un popolo, quello palestinese, privato della terra, dei beni, della memoria, della libertà, venga non solo schiacciato e oppresso, ma sterminato? Si può tollerare che i resistenti palestinesi che vogliono ritornare sulle terre a loro sottratte con la violenza e l’inganno, vengano bollati come “terroristi” e schiacciati come scarafaggi (espressione ricorrente fra gli ebrei israeliani che si riferiscono ai palestinesi di Gaza)? Si può tollerare che Israele violi ogni legge internazionale, che usi armi proibite agli altri Stati, che sfrutti l’Olocausto per legittimare il lento sterminio di un altro popolo? Si può tollerare che chi denuncia tutto questo venga chiamato “antisemita” e minacciato di sanzioni anche penali, in tutta Europa?
Si può tollerare il silenzio della “comunità internazionale”, davanti all’ultima spaventosa ondata di morti e feriti e mutilati, è diventato, infine, un timoroso belato di pseudo-protesta? Si può tollerare che i governanti di Israele, sostenuti dall’Amministrazione Usa, in un sfacciato gioco delle parti tra Netanhyau e Trump, sfidino il resto del mondo? Si può tollerare tutto questo carico di infamia, d’ingiustizia, di prepotenza contro il popolo oggi martire per antonomasia, quello palestinese? Quanti morti, quanti mutilati, quanti derubati dei loro beni e delle loro case, quanti internati in campi di concentramento dobbiamo ancora accettare, tra i palestinesi, quanti ulivi sradicati, quante case rase al suolo dai caterpillar, per dar vita a una azione internazionale, di popoli e di nazioni, contro Israele? Un’azione che non dovrebbe “rinunciare a nessuna opzione”, come amano dire i governanti israeliani, quando enunciano il proprio diritto/dovere di “difendere Israele”, in tutto il mondo, anche contro tutto il mondo. Ma il mondo, che fa? Non è tempo, infine, che gridi il suo “Basta!”?
* da “Alganews”