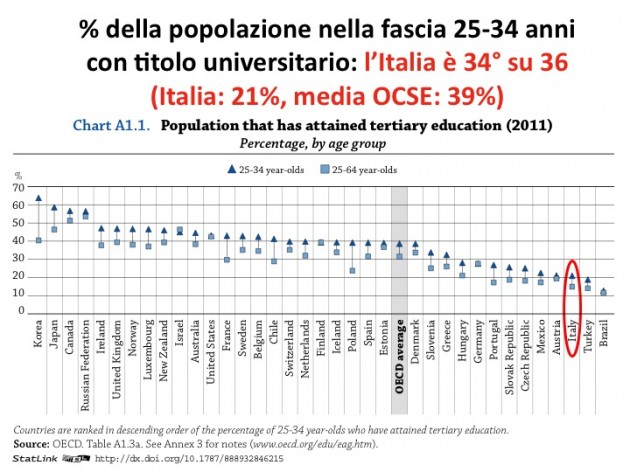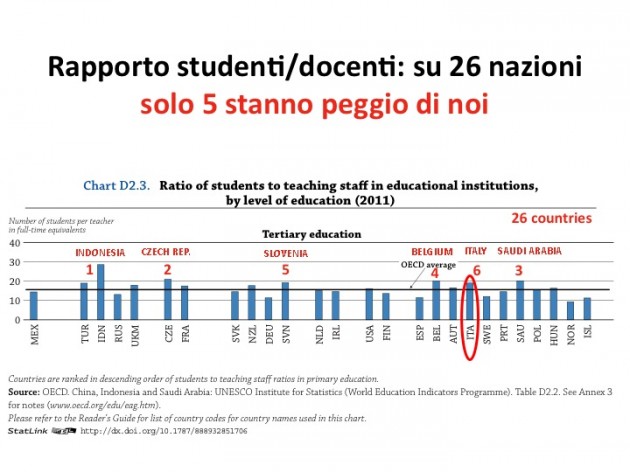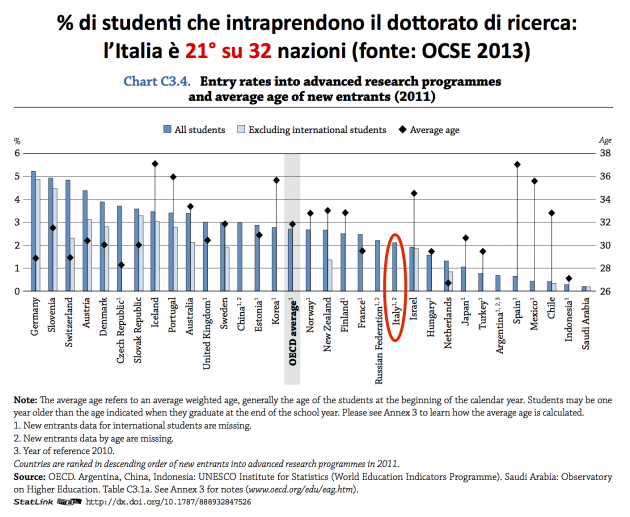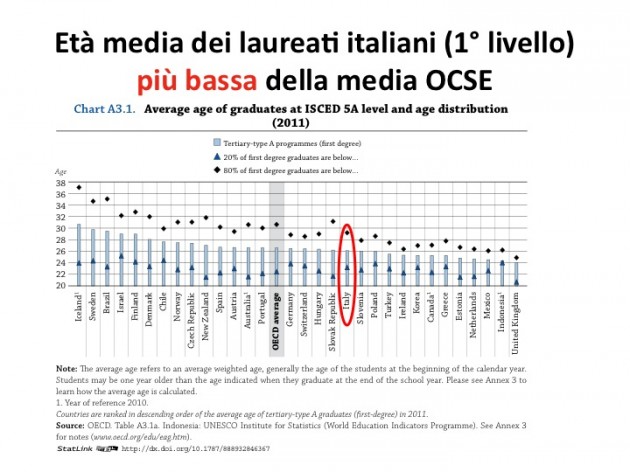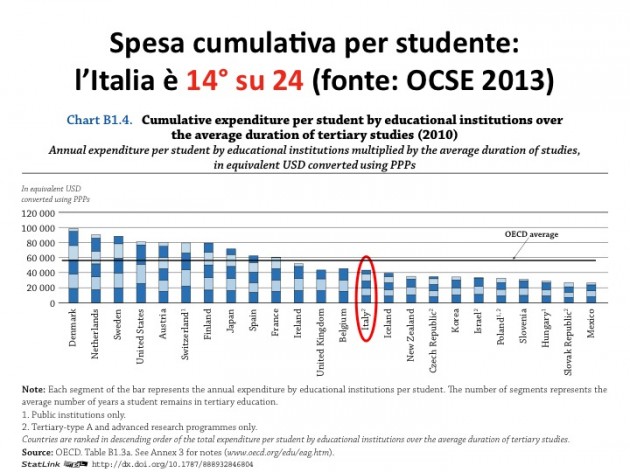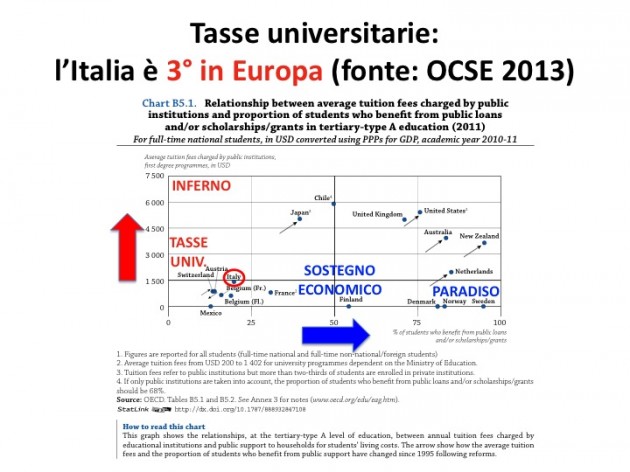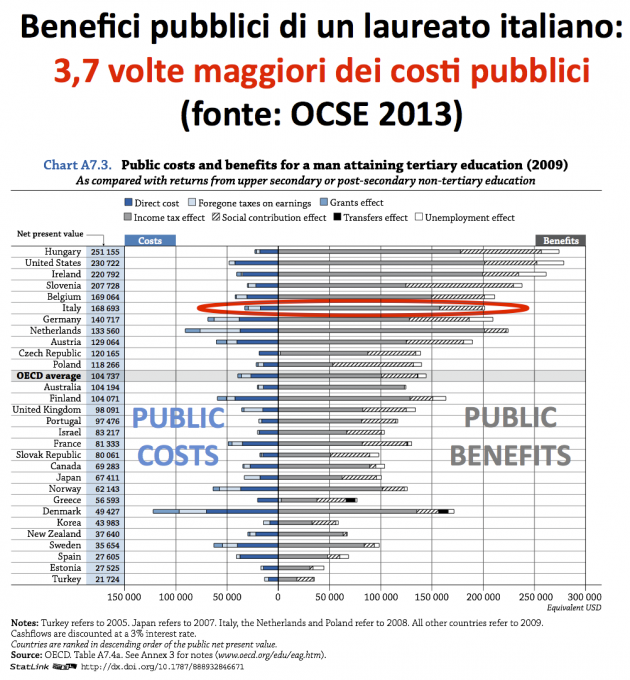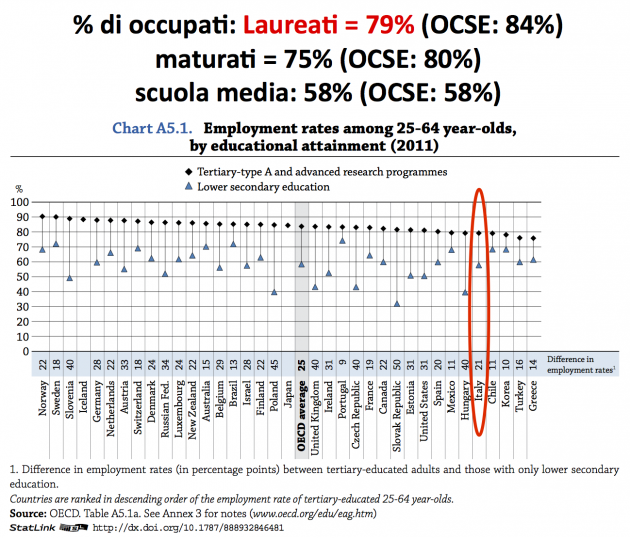Apologia della doxa.
Apologia della doxa.
Il “nuovo realismo” è letteralmente una trovata geniale. Il
paradigma, reso recentemente famoso da Maurizio Ferraris, che ne è il
promotore in Italia, e da quella fucina di idee progressiste che è il
gruppo La Repubblica[1],
è riuscito a ritagliarsi un posto nelle asfittiche e claustrofobiche
chiacchierate della filosofia italiana. Ma cos’è questa postura
intellettuale che tanto credito sembra ottenere da personalità quali
Umberto Eco – che, a dir la verità, già dai tempi de I limiti dell’interpretazione ha operato una svolta anti-ermeneutica – e dalle tante teste pensanti riunite in convegni quali quello di Bonn[2]?
Fondamentalmente è un ritorno ai fasti della doxa (δόξα), l’opinione
comune, ciò contro cui si erge il pensiero filosofico fin dalle sue
origini pre-socratiche[3].
Detta in maniera brutale, ma forse anche efficace, il nuovo realismo
afferma la consistenza oggettiva della realtà, al di là di ogni fenomeno
interpretativo. Il suo principale avversario non può che essere il
Nietzsche che nel noto frammento postumo dichiarava profeticamente:
«Contro il positivismo, che si ferma ai
fenomeni: “ci sono soltanto fatti”‘, direi: no, proprio i fatti non ci
sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constatare nessun
fatto “in sé”; è forse un’assurdità volere qualcosa del genere. “Tutto è
soggettivo”, dite voi; ma già questa è un’interpretazione, il
“soggetto” non è niente di dato, è solo qualcosa di aggiunto con
l’immaginazione, qualcosa di appiccicato dopo.
È infine ancora necessario mettere
l’interprete dietro l’interpretazione? Già questa è invenzione,
ipotesi. In quanto alla parola “conoscenza” abbia senso il mondo è
conoscibile; ma esso è interpretabile in modi diversi, non ha dietro di
sé un senso, ma innumerevoli sensi. “Prospettivismo”. Sono i nostri
bisogni, che interpretano il mondo: i nostri istinti e i loro pro e
contro. Ogni istinto è una specie di sete di dominio, ognuno ha la sua
prospettiva, che esso vorrebbe imporre come norma a tutti gli altri
istinti»[4].
Il baffone di Röcken, anche in questo frammento, non nega l’esistenza di un qualcosa posto là fuori, la realtà, ma sta sottolineando come il rapporto tra soggetto e mondo si dia sempre come dialettica orientata dal senso[5]. L’ingenuità del realismo che afferma l’inemendabilità
del reale, vale a dire la consistenza immodificabile
dell’oggetto-mondo posto davanti al soggetto, disconosce che questa
relazione è sempre situata in una prospettiva attraverso la quale i
“fatti” assumono un certo “valore”. In altre parole, non si nega la
possibilità di riscontrare empiricamente qualcosa di
inter-soggettivamente verificabile (“fatto”) ma che questo “qualcosa”,
nel momento in cui entra a far parte del nostro universo mentale,
assume un certo “senso”, un certo “posto”, che è a tutti gli effetti il
prodotto della singolarità irriducibile che siamo. A Nietzsche
interessa indagare questo “spazio vuoto” entro cui il mondo assume una
certa dislocazione per il soggetto. Un’analitica della verità entro cui
si dà la verità; o per essere più chiari: una ricerca delle condizioni
che determinano la prospettiva attraverso la quale ci affacciamo sul
mondo: il nostro belvedere. «Il mondo apparente è un mondo
considerato secondo certi valori: ordinato e sceverato in conformità a
certi valori, ossia, in questo caso, dal punto di vista dell’utilità,
in vista della conservazione e dell’aumento di potenza di un
determinato genere di animale»[6] . Nietzsche problematizza l’a-priori irriflesso entro cui si dispone la nostra immagine del pensiero (per dirla con Deleuze) perché è convinto che l’uomo non si disponga davanti ad un inemendabile, come pensano gli ingenui, ma che viva innanzitutto singolarmente[7] il proprio mondo.
Il nuovo realismo, sostenendo la tesi secondo cui Nietzsche (e i suoi
epigoni postmoderni) avrebbe esaltato il concetto di interpretazione
a detrimento della verità, intesa quest’ultima nella forma corrispondentista di «adaequatio rei et intellectus», oltre ad operare una lettura banale del baffone, ha voluto cercare di smontare i due presunti dogmi del postmoderno così riassumibili: «che
tutta la realtà sia socialmente costruita e infinitamente
manipolabile, e che la verità sia una nozione inutile perché la
solidarietà è più importante dell’oggettività»[8]( p. XI). Affermare l’inemendabilità di ciò che c’è, «il carattere saliente del reale»[9] , è l’imperativo di questa condizione post- postmoderna. Ma siamo sicuri che questa sia un’operazione filosofica emancipatoria come in più parti si sbandiera nel Manifesto del nuovo realismo? Noi non ne siamo convinti, tutt’altro.
L’idiota fantasia del Logos.
Come ho cercato di mostrare in Bentornata Ingenuità! L’oscena fantasia della ciabatta[10], il contributo preparato per il volume a più voci Il nuovo realismo è un populismo
, la svolta realista del circolo di Ferraris è il tentativo più
“facile” di andare incontro ad un’opinione pubblica che fa sempre più
fatica a star dietro a ragionamenti complessi e che, quindi, cerca le
scorciatoie della conoscenza in pillole, ciò che “può essere facilmente
compreso” e, magari, ridotto nella forma iconica cui tutti siamo
abituati per le frequentazioni dei social network. Ma è, soprattutto,
una procedura di esaltazione del senso comune e un tentativo di ridurre
la filosofia a pratica di ratifica dell’ovvio, della doxa. Se il
pensiero filosofico nasce per cercare di indagare i principi primi non immediatamente riscontrabili che organizzano la realtà, la sua trama, le sue leggi, il nuovo realismo
si pone in netta anti-tesi a questo spirito primordiale sancendo
l’inequivocabilità di ciò che appare davanti ai nostri occhi, del mondo
“così come lo vediamo”, del dato bruto disponibile alla chiacchiera di qualunque signor Simplicius.
Apparentemente questo andare incontro all’uomo comune dovrebbe essere
favorire la democrazia di massa anche nell’ambito della riflessione
teoretica. Non è così. Come ha più volte sottolineato Slavoj Žižek[11],
le operazioni ideologiche più pericolose sono quelle che si delineano
sotto altre vesti, magari facendo ricorso al consenso demagogico. E’
proprio il caso dell’operazione targata new realism in salsa italiana[12]
che, attraverso il consenso del grande pubblico, mira a ridurre la
filosofia a semplice operazione di ratifica dell’opinione comune. Prova
ad accattivarsi il plauso delle masse svendendo slogan che tutti gli
insofferenti la “fatica del concetto” anelano e, così operando,
attacca il filosofo “grillo parlante”, quello che mette la “pulce
nell’orecchio” proponendo e sollecitando la riflessione, l’attività
critica, la messa in discussione del senso comune, di ciò che appare
palese. Offre “ricette a buon mercato” che, in linea con i tempi (forse
con tutti i tempi), provano ad aggirare l’ostacolo attraverso il
ricorso alla soluzione più facile, la più ovvia, quella che semplifica
tutto e tutto dispone sul piano orizzontale della chiacchiera; quel
piano in cui si parla solo per affermare il diritto di aprire la bocca,
anche solo per darle fiato e per riempire l’aria di flatulenze
verbali. Si esalta l’opinione comune che tutti sappiamo quanto sia
evanescente, soggetta agli umori del tempo, alle sollecitazioni
strumentali alle varianti dell’emotività. Quanto sia condizionabile.
L’opinione comune, la doxa, era la grande avversaria della
filosofia presocratica, quella che si interrogava sulle condizioni di
possibilità dell’esistente, diffidando profondamente dell’ovvio buon
senso dell’uomo comune e ricevendo, in cambio, altrettanti sospetti; ci
ricordiamo tutti della servetta di Talete… Compito di questa filosofia delle origini
è scompaginare i valori comuni, le certezze dell’opinione pubblica, le
chiacchiere da osteria, quel sapere inconsapevole cui si riferiva
Braudel parlando di inconscio collettivo[13]
ancora tutto da indagare. Proprio questo sapere ingenuo che innerva
l’opinione pubblica è alla base di ogni totalitarismo. La radice di
quest’ultimo, il suo scopo principale, è quello di «costruire un uomo nuovo dal quale estirpare ogni tratto non sussumibile sotto una legge universale»[14]
, di ridurre ogni singolo uomo ad un pezzo intercambiabile all’interno
della specie, cancellandone la soggettività, intesa come singolare apertura al mondo. Elemento fondamentale per raggiungere questo scopo è la riduzione dell’immaginario collettivo ad Uno,
sottrazione delle differenze singolari a vantaggio dell’omologazione.
Ogni totalitarismo opera per riprodurre la specie umana sotto il segno
dell’Unità:
«Il dominio totale, che mira ad
organizzare gli uomini nella loro infinita pluralità e diversità come
se tutti insieme costituissero un unico individuo, è possibile soltanto
se ogni persona viene ridotta a un’immutabile identità di reazioni, in
modo che ciascuno di questi fasci possa essere scambiato con qualsiasi
altro. Si tratta di fabbricare qualcosa che non esiste.»[15]
In ogni totalitarismo la posta in gioco riguarda la creazione di un
certo tipo di individuo, parte di un insieme più ampio contraddistinto
dall’uniformità di quella che, con Deleuze, possiamo chiamare una certa “immagine presunta naturale del pensiero[16]”. Un uomo che non pensa ma che si limita a riconoscere il dato oggettivo che «appare impermeabile al sapere e fornisce un caso di patente divario tra conoscenza del mondo ed esperienza del mondo […].»[17]La presunta naturale corrispondenza tra pensiero e mondo sbandierata dal realismo ingenuo,
lungi dall’essere una filosofia dell’emancipazione è, a ben vedere, un
potente strumento a disposizione delle pratiche di governo che mirano
alla cancellazione delle differenze. Uno spirito reazionario
contraddistingue un pensiero, quello dei nuovi realisti, che si
propone di affermare la presunta oggettività del mondo e,
implicitamente, l’inutilità della riflessione filosofica, di ogni
procedimento teoretico che mira a mettere tra parentesi le certezze al
fine di indagarle, di sottoporle a critica. Questo “oggettivismo” (lo
possiamo chiamare così) da ragioniere si regge su quella che abbiamo
definito l’ idiota fantasia del logos[18], l’irriflessa postura intellettuale che «immagina il mondo esterno come il correlato di un’esperienza neutra»[19],
di un semplice riconoscimento dello stato di cose. Il sogno che
l’intero universo sia semplicemente quello che percepiamo, che non
nasconda abissi, traumi, zone oscure, fenditure, pericoli, è,
probabilmente, una delle fantasie fondamentali della specie umana, da
sempre intimamente minacciata dall’insondabile e, quindi, sempre sulla
difensiva. Un qualcosa di disponibile alle nostre pretese manipolative,
ecco, cosa prospetta il nuovo realismo per sedare le paure indefinite
della “società dell’ansia”. Ma questa ricetta di sicurezza, che
sacrifica la verità per un pò di sicurezza, è proprio ciò che offrono
tutti i totalitarismi, di qualunque colore. Si coltivano, si proteggono,
si organizzano, le esigenze, i desideri e le istanze della doxa al fine di disporne l’addomesticamento di massa. Sembra una procedura già vista…