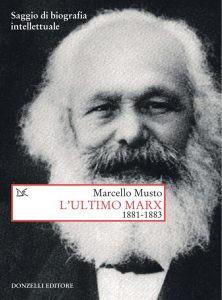«Il Comitato centrale ha deciso:
«Il Comitato centrale ha deciso:
poiché il popolo non è d’accordo,
bisogna nominare un nuovo popolo»
(B. Brecht)
Ora
che parte del polverone sollevato dalla vittoria di Trump si sta
posando, abbozziamo un’analisi un po’ più fredda del voto e un primo
bilancio politico di reazioni e prospettive.
All’immediato, lo
sbalordito establishment statunitense, non potendosi cercare un altro
“popolo”, sta correndo ai ripari lavorando a “normalizzare” la new entry
presidenziale - grazie al personale repubblicano rispettabile che entrerà nello staff e/o affidandosi al tentacolare stato profondo
- mentre la cupola finanziaria-militare coadiuvata dall’impero dei
media liberal che dirige il partito democratico sta sicuramente pensando
a come poter interrompere la corsa imprevista del presidente dei miserabili.
Sta di fatto che la presidenza Trump non solo potrebbe innescare
processi irreversibili ma, soprattutto, ha scoperchiato un profondo scontro dentro
l’establishment statunitense sulle strategie interne e esterne più
adatte a preservare l’impero del dollaro a fronte di una crisi sistemica
da cui non si riesce a uscire. È alla luce di questo scontro che si
tratta di discutere se l’opzione posta sul tavolo da Trump con buon fiuto politico, quella di una rinnovata unità nazional-popolare per rifare grande l’America,
non possa paradossalmente rivelarsi un buon investimento per la cupola
imperiale yankee negli svolti più duri a venire della crisi globale.
Comunque sia, il passaggio politico prefigurato dalla vittoria di Trump
comporta un profondo rimescolamento di carte nei rapporti di classe
interni e a scala geopolitica e geoeconomica di cui si tratta di
tracciare le possibili dinamiche contraddittorie. Vediamo.
Sul versante interno, Trump è il paradossale
erede di Obama. Almeno per tre ordini di motivi. Primo, perché la sua
vittoria è il risultato del fallimento completo del primo presidente
nero della storia statunitense sul piano economico-sociale, un
fallimento riassumibile nella inesorabile sequenza: no ripresa
economica, no recupero di posti di lavoro decenti, no riforma sanitaria
come diritto universale (bensì come costrizione all’acquisto di una
assicurazione privata), raddoppio del debito pubblico pro salvataggio
del mondo finanziario, inasprimento delle questioni razziali. Chi, anche
e soprattutto a sinistra, ha cianciato in questi anni di recovery modello Obama (e Draghi!) contro l’austerity di marca tedesca meriterebbe il benservito (http://www.infoaut.org/index.php/blog/global-crisis/item/12203-tutti-per-la-crescita-intanto-negli-states). In secondo luogo, Trump ha ripreso la bandiera del change, va da sè, in un contesto non di speranza bensì di disperazione e/o rancore da parte dei leftbehind, quelli lasciati indietro dalla globalizzazione finanziaria e dalla digitalizzazione dell’economia, e di ampi settori di middle class
a rischio declassamento, reale o percepito. Terzo, Obama ha fallito nel
rivitalizzare per un rilancio dell’impero il fronte progressista,
dunque ora tocca far leva, attenzione: per il medesimo obiettivo, sulla
difesa “nazional-sociale” del popolo americano (http://www.infoaut.org/index.php/blog/prima-pagina/item/16523-iniziata-la-fase-b?).
È alla luce di ciò, e non astrattamente, che va fatta un’analisi “di classe” del voto uscito da quella che è stata forse la più dura e polarizzata campagna presidenziale dal ’68 (http://www.infoaut.org/index.php/blog/segnalazioni/item/17716-trump-president).
Se è vero che il voto per Trump in termini assoluti non è affatto stato
una valanga -anzi inferiore a scala federale a quello per H. Clinton- è
altrettanto indiscutibile che ha delimitato e segnato il campo dello
scontro quanto a temi e umori. Così pure, se la composizione sociale dei
trumpster è trasversale, dal tradizionale elettorato repubblicano bianco/a di destra a settori importanti di working class, è evidente che sono stati questi ultimi, volgendo le spalle al partito democratico in stati decisivi, a fare la differenza unitamente alla forte astensione-disaffezione dell’elettorato femminile, giovanile e black
attivato da Obama nel 2008. Il tono di fondo di questa elezione l’ha
così dato una richiesta, contraddittoria quanto si vuole, di discontinuità. In particolare, non si sottolineerà mai abbastanza il fatto che proprio dall’Amerika -paese incantato di illimitate possibilità
in cui macchinismo e assurdo vanno a braccetto, secondo l’allegoria
straordinaria che ne fece Kafka- stia salendo dal profondo della società
una richiesta di limiti da porre alla globalizzazione e
all’interventismo militare imperiale. Anche se si resta, per ora, sul
terreno poco impegnativo della mobilitazione elettorale.
Insomma, i
voti non si contano, si pesano. Trump ha dato voce a dinamiche in atto
tanto più rilevanti in quanto siamo al centro del capitalismo mondiale.
L’ha saputo fare, e qui sta una chiave del suo successo, collocandosi in
buona misura al di là del tradizionale schema
destra/sinistra agitando al suo posto temi che rimandano alla frattura
vincenti/perdenti della globalizzazione e élite/gente comune, temi
peraltro affiorati anche nella campagna per la nomination democratica di
Sanders ma giocati qui ancora troppo in chiave di sinistra liberal. Inutile chiedere di cogliere tutto ciò a chi si è adagiato compiaciuto sulle narrazioni dei media mainstream e ora non sa far altro che strillare al “razzista” o, udite, al “fascista” mentre avrebbe fatto meglio a rivedersi… Taxi Driver.
La vittoria di Trump è un segnale di contraddizioni di classe e
geopolitiche che approssimano, assai più di quel che si dava con Obama, i
nodi di fondo del capitalismo statunitense e globale. Dire che essa è
il prodotto colpevole dell’omologazione della “sinistra” è troppo e
troppo poco al tempo stesso: troppo perché la “sinistra” occidentale è
oramai strutturalmente legata al capitale imperialista (a meno di
pensare ingenuamente in termini di “tradimento”) e di qui non si torna
indietro; troppo poco perché per qualunque analisi seria questo è solo
il punto di partenza e non d’arrivo della questione (a meno di
accontentarsi del concetto di populismo come passepartout e non come qualcosa che va analizzato con cura come abbozziamo nella postilla qui sotto).
Ma il trumpismo
non è solo questo (e già basterebbe). Né, quasi a ribadire ingenuamente
il mito del sogno americano, si tratta dell’ennesimo outsider che ce
l’ha fatta. Dietro il neo-presidente c’è uno scontro reale e
importantissimo interno all’establishment statunitense. Se è un
outsider, in alto le sue posizioni non sono comunque
del tutto isolate e prive di sponde sia sul versante delle scelte
strategico-militari sia su quello delle ricette economiche di uscita
dalla crisi. Sul primo, al di là delle semplificazioni qui inevitabili, a
scontrarsi sono al momento due schieramenti ben demarcati. Da un lato
c’è l’alleanza tra neocons e interventisti democratici, radicata al
Pentagono oltrechè al Dipartimento di Stato, che ben rappresentata da Killary
Clinton ha ricevuto un inaspettato quanto sonoro schiaffone: essa
puntava a proseguire e se possibile accelerare la traiettoria di scontro
duro, a un tempo, con Russia e Cina a colpi di regime change, procurato caos geopolitico e nuovo contenimento
in Asia Orientale. È però evidente che i tempi non sono maturi per
passare a un’aggressione aperta, come peraltro ha fatto notare
Brzezinski (http://www.the-american-interest.com/2016/04/17/toward-a-global-realignment/),
non proprio una “colomba”. Le sconfitte statunitensi in Georgia,
Ucraina e Siria, la difficoltà a rinvenire alleati disponibili a un
corso più duro anti-russo e anti-cinese, la tenuta interna e
internazionale di Pechino nonostante i segnali di crisi finanziaria (http://www.infoaut.org/index.php/blog/global-crisis/item/15406-crash-tutto-cinese),
l’indubbia capacità strategica e tattica di Putin - tutto ciò consiglia
un rinvio dello scontro che lo prepari sia all’interno che all’esterno,
in particolare lavorando a separare Mosca da Pechino. È
questa, grosso modo, la posizione dell’altro schieramento, di Trump e
di quei pezzi di establishment che l’hanno aiutato a vincere (come si è
visto dall’intervento anti-Clinton della Fbi). Certo, il rischio è qui
che dando tempo agli avversari si acuiscano le difficoltà internazionali
degli Usa con ricadute gravissime in termini di crisi interna, mentre
non ci sono garanzie che si ricostituisca un compatto fronte occidentale
(come le continue frizioni con la Germania in questi anni di presidenza
Obama hanno evidenziato). La posta in palio è dunque drammatica e
potrebbe portare a uno scontro aperto all’interno dell’élite.
All’incrocio
con questi nodi si pone l’altro versante del problema: quale strategia
di uscita economica non diciamo dalla crisi ma dal rischio declino della
potenza Usa? Se all’immediato Trump non può permettersi una brusca
interruzione della politica monetaria fin qui impostata dalla Federal Reserve, è però vero che anni di tassi di interesse bassissimi e ripetuti Quantitative Easing
non hanno rilanciato gli investimenti e dunque occupazione “buona”, al
contrario le diseguaglianze economiche e la polarizzazione sociale si
sono accresciute mentre si è ingigantita una nuova bolla speculativa.
Difficilissimo per Trump barcamenarsi in questo quadro (tanto più che la
Fed afferisce al momento al campo a lui avverso e sembra invece intenzionata, guarda caso, ad alzare a breve
i tassi di interesse). Un corso a là Reagan di dollaro forte e maggiore
indebitamento, anche se per investimenti infrastrutturali piuttosto che
per il riarmo, cozza, almeno, con la crescente indisponibilità di
attori decisivi come la Cina, e non solo, di continuare a finanziare
Washington con l’acquisto dei suoi Bond e potrebbe addirittura
incentivare le tendenze oggi embrionali alla de-dollarizzazione degli
scambi internazionali. Al tempo stesso, la spinta alla rilocalizzazione
di parte dell’industria manifatturiera, in sé non facile e comunque
dalle più che incerte ricadute occupazionali dati i livelli attuali di
automazione, scatenerebbe gioco forza uno scontro economico tra blocchi
regionali in competizione, oltre a minare il prestigio “imperiale” degli
Stati Uniti, quel soft power fin qui rivelatosi indispensabile
nel mantenere alleanze e nel fissare gli standard della
globalizzazione. Una cosa sembra certa: anche per ragioni interne -
Trump dovrà in qualche modo venire incontro alle richieste che
provengono dalla pancia della società americana - un tale inasprimento
delle tensioni economiche internazionali (altro che isolazionismo!)
difficilmente potrà essere evitato.
È questo il punto cruciale. La domanda è: un corso di crescente nazionalismo economico,
volto a scaricare all’esterno i costi della crisi globale in misura
ancor più secca di quanto avvenuto con Obama - in particolare sui paesi
Brics, Cina in testa, e su un’Europa sempre più divisa e confusa - sarà
in grado di consolidare ampliare e unificare il fronte sociale interno prima
delle sue possibili ricadute negative sull’economia e dunque sulle
condizioni della working e della middle class in un paese già fortemente
polarizzato? E prima che, per converso, si formi un fronte esterno
anti-Usa? È su questo nodo, attraversato dalla variabile crisi, che si
gioca la possibilità per l’èlite di canalizzare e trasformare lo
scontento “populista” in mobilitazione “nazional-sociale” facendo di
Trump una carta in mano ai poteri forti dell’imperialismo a stelle e
strisce piuttosto che l’innesco di una crisi interna dai contorni
imprevedibili. Certo, a costo di porre fine alla globalizzazione così
come l’abbiamo conosciuta ad oggi e di ristrutturare gli equilibri nel
gotha economico mondiale, che è quanto inquieta ad oggi la cupola
finanziaria e mediatica. Resta che davanti a noi abbiamo più
instabilità, a tutti i livelli: la crisi globale sta voltando pagina e
mostra oramai il suo lato propriamente politico, piaccia o non piaccia.
__________________________
Postilla politica sul populismo: contro una falsa alternativa
“Il noto proprio perché è noto non è conosciuto” (G.W.F. Hegel)
La
vittoria di Trump - dopo la Brexit, con la crisi evidente dell’unità
europea e il diffondersi in Occidente di mobilitazioni e umori
anti-élite - ha suscitato due reazioni opposte e speculari nella
sinistra nostrana su come leggere e rapportarsi al populismo
tanto più che di questo sta emergendo il “lato cattivo”. Ne abbozziamo
in queste tesine provvisorie una caratterizzazione ideal-tipica (nb) per
poi tentare di procedere oltre la loro antitetica
complementarietà. Va da sé che da entrambi i lati vengono colti aspetti
reali, ma appunto solo aspetti che nella loro unilateralità nota perdono il tutto in divenire che resta non conosciuto.
° Gli uni, gli anti-populisti,
liquidano la cosa come fenomeno di destra, riducibile a razzismo e
nazionalismo e più o meno contiguo al fascismo, e danno sostanzialmente
per persa quella parte di working class, sbrigativamente catalogata come
“vecchia” composizione di classe, che va o andrà a collocarsi su quel
terreno. A fronte di ciò propongono senza sostanziali ripensamenti more of the same quanto ad antidoti contro le passioni tristi
emergenti: lotta per i diritti (sociali in quanto) umani, anti-razzismo
moralista, globalismo “dal basso”, con l’individualismo liberal
sempre nel cuore aggiornato all’altezza di un’economia della conoscenza
che permetterebbe l’autodeterminazione delle intelligenze creative se
solo si democratizzassero le piattaforme digitali esistenti. Di qui
micro-politica e proliferazione delle identità nella lotta per il
riconoscimento (da parte di chi?). Ma poiché la dimensione macro non
sparisce d’incanto, prevale un sostanziale europeismo a prescindere
che, chissà, con il paese della Libertà oscurato dal nuovo fascismo
potrebbe financo recuperare “criticamente” -se non fosse per un
inveterato anti-tedeschismo duro a morire- l’invisa Merkel tenuta a
battesimo dal nobel-per-la pace Obama come novella anti-Trump (tanto più
che ha già dato prova di sé come eroina del profughismo). Comunque sia, gli anti-populisti rinnovano, volenti o nolenti, la convergenza di sinistra e liberaldemocrazia
in nome dei Diritti Universali (che, va da sé, un capitalismo ben
temperato dal conflitto non può non concedere) propri dell’Occidente democratico (mai chiamarlo col suo nome: imperialismo) fuori dal quale non ci sono che terribili regimi autoritari. In forme nuove siamo qui all’ala sinistra della borghesia globalista già progressista, e non sarà certo una sfilza di post (postfordismo, postmoderno, postindustriale, postnazionale ecc.) a cambiare la cosa.
° Gli altri, i filo-populisti antisistemici,
vedono nel fenomeno la nemesi di una sinistra che ha sposato il
neoliberismo e dunque, sull’onda della sua crisi definitiva, l’aprirsi
di possibilità anti-sistema di cui i populismi sovranisti sarebbero
appunto la prima manifestazione. Essi, pur col rischio di essere in
ritardo di fase rispetto al fenomeno dei populismi di “destra” e con la
tendenza a edulcorare una realtà ben altrimenti complessa, hanno dalla
loro la corretta individuazione della dinamica di fondo che lega, oggi,
le istanze delle classi in senso lato sfruttate alle rivendicazioni
sovraniste e nazionali come terreno di un’inedita e rinnovata lotta di classe. Ma se questo è il loro merito, fraintendono poi totalmente la natura dei soggetti
sociali coinvolti in questa dinamica di resistenza facendone
illusoriamente un campo di forze esterno a quei processi che hanno
portato la sinistra a diventare quel che è oggi, cioè tutta interna alla
logica del capitale. Questi soggetti vengono infatti accreditati di una
natura anti-sistemica già data che per esplicarsi in
maniera conseguente abbisognerebbe solo di una direzione adeguata. Il
problema diventa qui quello di evitare l’inconseguenza del populismo,
problema cui si risponde ponendosi sulla sua medesima
direttrice e portando alle estreme conseguenze le rivendicazioni di
sovranità nazionale, anti-europeismo, no euro, ecc. Non solo, dunque, si
dà una lettura eccessivamente lineare dei processi in atto, ma ci si
illude di poter giocare un ruolo (di “vera” sinistra?) che alla fin fine
consiste nel porsi alla coda di settori di borghesia in via di
declassamento che, credendo di agire per sé, finiscono per favorire
agenti infinitamente più forti (per l’Europa: gli Usa beneficiari di una
eventuale fine dell’euro).
° In realtà, per iniziare a impostare
una via d’uscita dalla suddetta contrapposizione speculare, è bene non
perdere di vista il fatto che l’interiorizzazione del diktat
capitalista-neoliberista non vale solo per le rappresentanze politiche
di sinistra ma nella fase della finanziarizzazione ascendente ha
coinvolto in profondità quegli stessi soggetti che oggi, nella crisi, cercano nuove risposte al di fuori di quella sinistra senza
per questo rappresentare un “fuori” rispetto ai processi di sussunzione
reale, di neo-industrializzazione delle attività, di sottomissione
reale e simbolica allo spettacolo integrato sub forma di
capitale fittizio. Al contrario, è da questo suo essere del tutto
“dentro” il capitale -a differenza del vecchio movimento operaio che
manteneva una sua identità distinta da esso, un suo “fuori” relativo che
ha dapprima permesso di tener viva la dialettica lotte operaie/sviluppo
capitalistico ma è poi stato fagocitato dagli stessi successi ottenuti-
è a partire da questa collocazione rispetto al capitale che il nuovo
proletariato inclusivo di fette consistenti di classe media si ritrova
sempre più trasformato ora in “cittadino” inascoltato dal potere
(variante buona del populismo) ora in “superfluo” (variante cattiva),
alla ricerca disperata di soluzioni per così dire neo-riformiste
e neo-sovraniste, ambivalenti e spesso “sporche e cattive”. Che queste
ricette si presentino come populismo “anti-sistema” la dice lunga su
quanto si siano oggettivamente ristretti i margini di tolleranza del capitale totale
rispetto a qualsivoglia deviazione dei soggetti dal tracciato previsto,
ma ci dice anche della sua crisi di capacità di mediazione sociale e
politica.
° La radice di questa ambivalenza,
aperta a esiti opposti, sta appunto nella collocazione oggettiva del
proletariato all’interno dell’odierno sistema di produzione che ha
distrutto o sussunto gli spazi ancora autonomi di riproduzione materiale
e simbolica della vita sociale. Tale internità, combinata -in
Occidente- con un relativo margine di riserve economiche pur a fronte di
un futuro sempre più nero, dà luogo a una situazione contraddittoria:
le soluzione ricercate per uscire da una crisi che non è solo economica
ma di senso, vanno nella direzione di un “comune” che se è già critica
dell’individualismo sfrenato è però ancora tutto interno a questo
sistema di vita e di produzione (non a caso simboleggiato dalla
nazione), ciò che lo rende foriero di rischiose contrapposizioni tra un
“noi” e un “voi” secondo linee non di classe ma di altro tipo. È come se
per riappropriarsi della propria natura comunitaria -meta storica, non
mitica origine essenzialista- il proletariato dovesse prima passare fino
in fondo attraverso la comunità fittizia ma non per
questo meno reale del Capitale totale-spettacolare. E però in quel “noi”
ci può stare una amplissima varietà di soggetti accomunata da un’unica
condizione sociale: forza-lavoro di fatto proletarizzata, rigidamente
dipendente da chi muove le leve del grande capitale anche quando ti
fanno credere che godi di autonomia economica o cognitiva, e vita
espropriata. E comincia a starci anche una crescente umanità che per il
sistema è irreparabilmente superflua, neanche più esercito industriale
di riserva ma vera e propria eccedenza inutilizzabile anche come massa
per ricattare chi lavora. Soprattutto, si fa qui strada la sensazione di
non poter più vivere come prima, che un qualche tipo di rottura diventa
necessaria.
° La domanda politica, alla luce di tutto ciò, non
è come evitare lo scivolamento e/o l’inconseguenza del populismo.
Perché, coniugandosi sull’asse noi/voi (anche laddove il voi pare
all’inizio comprendere le sole élite), è scontato non solo che esso sia
inconseguente nelle sue istanze anti-establishment ma anche che debba
portare, prima o poi, allo scontro tra poveri e fare da supporto alle
crescenti rivalità tra nazioni. Ma il punto è che non è
scontato che trascini con sé su questa deriva i soggetti, o tutti i
soggetti, che in esso si riconoscono o transitano come istanza di
resistenza. La domanda utile da un punto di vista effettivamente
antagonista al sistema è un’altra: a quali condizioni
il populismo può essere superato in avanti e scomposto? Come entrerà in
contraddizione non con se stesso ma con le istanze e i soggetti? Come
separare nelle pur timide, finora, richieste di potere la dimensione
“sovranista” (che è in fondo un tentativo di recuperare potere sulla
propria vita) da quella nazionalista? Questioni complesse ma ineludibili
su cui si giocherà, in un futuro forse neanche troppo distante, la
partita: che cosa sono gli amici del popolo?
° Solo con queste domande ben presenti è possibile e necessario sporcarsi le mani
per cercare di rovesciare queste dinamiche contraddittorie - i
populismi sono all’inizio di un percorso che non sarà affatto lineare,
tanto più che la crisi globale si appresta a entrare nel suo secondo
girone infernale - in un senso anticapitalista, che è l’unico che ci
interessa. È bene aver presente che in prima istanza non si tratta di
capacità tattiche di qualcuno o di approntare oggi una qualche
“direzione alternativa”. Ne va innanzitutto di profondissimi
sconvolgimenti economici e sociali, di una scomposizione del sistema e
della collocazione delle classi in esso, e soprattutto della
costituzione di un soggetto ampio antagonista che possa con la sua lotta
attirare (o neutralizzare) quegli strati che altrimenti cercherebbero
altre, inquietanti sponde. Solo su questa base può darsi un intervento
politico non minoritario che sappia rapportarsi ai temi e alle forme
della realtà effettuale e non all’immaginazione di essa.
Intervento che necessita di una tendenza, anche programmatica, in grado
di demarcarsi -senza estremismi ma seccamente e su tutti i piani- dallo
spettro “destra/sinistra” così come è definito dalla politica borghese.
La linea amico/nemico vogliamo tracciarla noi e non assumerla dai nostri
nemici.
Note