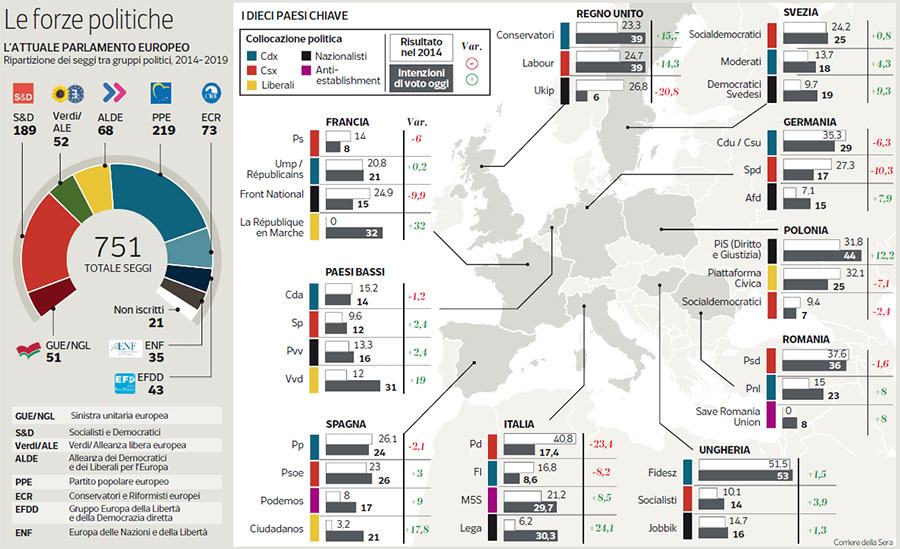È
ormai difficile negare che l’Italia si trovi in un “momento populista”,
caratterizzato dall’emergere di forze politiche nuove, nuovi discorsi
politici e nuova costruzione di senso comune. Si tratta di una fase che,
in altri tempi e con altra sensibilità, Antonio Gramsci aveva chiamato
«guerra di movimento», un «interregno», una fase di passaggio verso la
successiva stabilizzazione egemonica di un ordine. La rapida ascesa di
partiti e personalità nuove (M5S, Salvini), l’altrettanto rapida caduta
di altre (Monti, Renzi), l’elevata mobilità elettorale (il M5S che in
pochi anni balza al 32,7% o la Lega che passa dal 4% al 32% dei sondaggi
odierni) e la politicizzazione estrema di alcuni temi (Europa,
migranti, sicurezza) sono tutti segnali di una fase di intensa
ridefinizione dello spazio politico, dei soggetti in campo e delle loro
parole d’ordine.
È
ormai difficile negare che l’Italia si trovi in un “momento populista”,
caratterizzato dall’emergere di forze politiche nuove, nuovi discorsi
politici e nuova costruzione di senso comune. Si tratta di una fase che,
in altri tempi e con altra sensibilità, Antonio Gramsci aveva chiamato
«guerra di movimento», un «interregno», una fase di passaggio verso la
successiva stabilizzazione egemonica di un ordine. La rapida ascesa di
partiti e personalità nuove (M5S, Salvini), l’altrettanto rapida caduta
di altre (Monti, Renzi), l’elevata mobilità elettorale (il M5S che in
pochi anni balza al 32,7% o la Lega che passa dal 4% al 32% dei sondaggi
odierni) e la politicizzazione estrema di alcuni temi (Europa,
migranti, sicurezza) sono tutti segnali di una fase di intensa
ridefinizione dello spazio politico, dei soggetti in campo e delle loro
parole d’ordine.
In un contesto come questo sembra perdere di
significato la contrapposizione che aveva sostenuto quasi tutte le
battaglie contro il neoliberismo degli ultimi anni: quella tra un
discorso radicale-democratico di attivazione e contestazione del potere,
e uno istituzionale governamentale di contenimento attraverso la
spoliticizzazione. Al contrario, oggi più che mai il discorso del potere
è un discorso populista e radicale, mentre la sua contestazione sembra
relegata al piano della critica morale e paternalista. La crisi del
neoliberismo ha riattivato le “faglie politiche” sulle quali si
costruiscono i soggetti collettivi, e la destra razzista e i
qualunquisti nostrani hanno compreso meglio di chiunque altro le
opportunità di quest’apertura.
Il populismo razzista e quello democratico
È
stata la crisi del 2008 a creare le condizioni per l’esplosione degli
assetti politici che si erano consolidati negli anni Novanta e a far
emergere lo spazio per nuovi discorsi e nuove formazioni. Non si tratta
certo di un fenomeno solamente italiano, anche se da noi il successo
della sua declinazione qualunquista (M5S) e poi razzista (Lega) ha
raggiunto intensità e forza maggiori. Nel campo dei soggetti radicali e
democratici, invece (cercherò quanto più possibile di evitare la
connotazione “di sinistra”, ormai preda di un immaginario compromesso),
si è avuta una prima ondata populista-democratica, tanto negli Usa
quanto in Europa: ne sono protagonisti Podemos in Spagna, Bernie Sanders
negli Usa e il Labour di Jeremy Corbyn in Gran Bretagna, a cui sembra
stia seguendo una seconda ondata populista-sovranista, rinvenibile in
alcune correnti de La France Insoumise, nella Aufstehen di Sahra
Wagenknecht in Germania e in alcuni sparuti epigoni italiani.
Oltre
ad essere molto più deboli dei cugini francesi e tedeschi, i politici e
intellettuali sovranisti italiani “di sinistra” (e qui è d’obbligo
l’uso del termine) hanno due caratteristiche peculiari:
la prima è che
sembrano formulare la loro proposta politica non in contrapposizione al
populismo di destra (come fa Melenchon per esempio, pur contendendogli
l’elettorato) ma alle altre declinazioni della sinistra, finendo così
per sostenere una parte dei programmi e delle politiche dell’avversario;
la seconda è di presentarsi con quelle stesse facce che fino a qualche
mese fa facevano parte, seppur criticamente, di quei partiti e di quei
circoli intellettuali che hanno applicato o giustificato le ricette
neoliberali degli ultimi vent’anni. Insomma, nessuno con la storia e la
credibilità di un Sanders o di un Corbyn, piuttosto la solita vecchia
storia dell’amante deluso che si trasforma in detrattore.
Non sarebbero
quindi degni di nota, o di critica, se non rischiassero di inficiare una
causa ben più importante, quella del populismo democratico-radicale
della “prima ondata”, che ha radicalmente innovato lo scenario politico
europeo e creato le condizioni per dare filo da torcere al populismo
razzista dilagante.
In Italia quell’onda non è mai arrivata, e
nell’ultimo decennio in molti si sono chiesti come fosse possibile che
proprio il paese che aveva avuto il più grande partito comunista e la
più lunga stagione di mobilitazione d’occidente potesse rimanere inerte
davanti a una tale rinascita internazionale di forze radicali e
democratiche. La risposta sta forse proprio nella saturazione della
memoria che queste esperienze hanno lasciato, provocando due effetti
opposti ma speculari nei mille gruppuscoli della “diaspora”: da una
parte, come eredità del Pci, la nostalgia passatista del Soggetto
politico (maiuscolo), la sua mitizzazione, ossificazione e sostanziale
riproposizione come schema oggi vuoto di significato; dall’altra, come
eredità della contestazione “da sinistra” al Pci, la paura della sintesi
politica, l’incapacità di considerare lo Stato come un campo di forze
invece che come un mero strumento repressivo, la ritrosia a invadere il
campo avversario per paura di essere “contagiati”. Ma la storia procede
anche per salti e cosa ne sarà della formazione politica delle nuove
generazioni nessuno può saperlo. Per questo, se da una parte occorre
difendere la causa del populismo democratico dal populismo razzista e
qualunquista, dall’altra occorre contrastare la sua appropriazione da
parte dei sovranisti nostrani “di sinistra”. Quello che ci occorre, in
breve, è un populismo democratico non sovranista.
Tre insegnamenti di Laclau
In
questo compito può essere utile rileggere Ernesto Laclau, filosofo
argentino scomparso recentemente e unanimemente considerato il teorico
del populismo democratico. La fortuna di Laclau è molto cresciuta
nell’ultimo decennio, tanto da diventare un solido riferimento per molti
intellettuali e dirigenti politici della prima ondata populista. Dalle
pagine dei suoi libri possiamo recuperare almeno tre insegnamenti utili
per salvare il populismo democratico dalla deriva sovranista.
Il
primo è proprio che… il popolo non esiste. Non esiste come dato
biologico, non esiste come espressione di un’“omogeneità culturale”, non
esiste nemmeno come entità sociologicamente definibile. Esiste invece
il popolo come costruzione politica (e polemica), composto da gruppi e
individui diversi che si articolano, cioè si legano e si organizzano
sulla base di un discorso comune. Così concepito, il popolo non annulla
affatto le differenze al suo interno, ma riesce comunque a presentarsi
come un soggetto politico unitario perché ciò che tiene insieme le sue
parti è la comune avversione a un nemico politico. È abbastanza chiaro
come questa definizione implichi la possibile esistenza di diversi
popoli, anche all’interno della stessa platea, definiti sulla base del
tipo di articolazione (solidaristica o securitaria ad esempio) e del
tipo di nemico scelto (l’1% più ricco o i migranti). Se quindi il popolo
evocato dal fronte razzista e qualunquista è omogeneo, spaventato,
razzista, il popolo del populismo democratico può e deve essere plurale,
vitale, inclusivo. Non è questione di buoni sentimenti, ma di mettere
in campo una diversa interpellazione degli stessi soggetti, un
meccanismo di unità che ricomponga un blocco sociale attorno a diverse
parole d’ordine e che identifichi nemici diversi. Al contrario, i
“sovranisti” di sinistra sembrano aver assunto dall’avversario la falsa
contrapposizione tra un popolo rozzo, preda di bassi istinti, e un’élite
intellettuale e sofisticata, lontana dai supposti “bisogni” di questo
soggetto omogeneo. Chi accetta questa visione, chi si rassegna a fare la
politica di queste paure, è subalterno al discorso dell’avversario, ma
soprattutto sarà sempre politicamente perdente di fronte alla proposta
originale.
Il secondo insegnamento che possiamo trarre della
teoria del populismo di Laclau riguarda il ruolo dello Stato e del
discorso nazionalista. Su questo tema si può dire che il sovranismo
cambi ragione sociale al populismo democratico: si passa infatti da una
critica di classe (espressa tramite la contrapposizione tra alto e
basso) ai meccanismi antidemocratici, neoliberali ed elitisti della
costruzione europea, alla difesa dello stato nazionale contro le
ingerenze esterne. Non più quindi la critica all’Europa neoliberale come
strumento per la lotta di classe internazionale, ma la critica
all’Europa tout court tramite la costruzione di un’identità
nazionale, il tutto condito con un bel po’ di nostalgia per l’epoca
fordista a cui corrispondeva uno Stato tanto protettivo quanto
disciplinare. È così che la domanda per una democrazia radicale, che al
fondo significa possibilità di influire sulle decisioni attraverso una
lotta per l’emancipazione di chi sta in basso, si è trasformata in
sovranismo, rivendicazione ultima dello spazio nazionale come difesa
dalle invasioni straniere, tanto quelle dei flussi del capitale globale
quanto quelle dei migranti. È in questo scivolamento che la ragione
sociale è cambiata, il discorso di classe abbandonato, la giusta
rivendicazione di uno spazio di decisione democratica trasformato in un
discorso subalterno a quello dell’avversario. Anche su questo punto – il
ruolo dello Stato in una politica populista democratico-radicale –
Laclau può venirci in aiuto. Benché spesso si presupponga che il
filosofo argentino postuli un unico spazio politico a disposizione,
quello statale-nazionale, caratterizzato da solidi confini
(territoriali, istituzionali, culturali) e piena sovranità (politica,
economica), in realtà questi elementi non vengono mai esplicitati come
precondizioni dell’emersione di una logica populista. Al contrario.
Scrive Laclau: «Quando diciamo “Stato” ci riferiamo a un concetto che
indica una funzione ordinatrice all’interno di una formazione sociale.
Può essere lo Stato-nazione, ma non necessariamente solo questo, può
anche riguardare uno Stato sovranazionale, oppure una serie di funzioni
ordinatrici che non hanno nulla a che vedere con la dimensione pubblica
nel senso stretto del termine». Ecco allora un secondo insegnamento da
tenere presente: non è la forma di questa azione ordinatrice che conta
(Stato-nazione, Stato sovranazionale o una configurazione comune
oltre il pubblico e il privato), ma il fatto che essa si crei, come si
crei e in che direzione si crei a determinare l’importanza dell’azione
populista. Rimettere il populismo democratico sui suoi piedi significa
anche non fare dei mezzi contingenti di una battaglia tattica (la
critica all’Europa neoliberale) lo scopo ultimo dell’azione populista
(la difesa della sovranità nazionale).
Un terzo insegnamento che
possiamo trarre da Laclau è che nessuna configurazione politica è
stabile, soprattutto all’interno di quel momento populista dove le
identità si modificano di continuo e la loro articolazione non è affatto
definitiva. Questo non è “un paese di destra”, come ieri ci dicevano i
complici delle riforme neoliberali e oggi ci ripetono i compagni
demotivati. Nel linguaggio un po’ formalistico di Laclau: perché si
manifesti un nuovo popolo non serve che «tutti gli elementi di una
configurazione emergente debbano essere radicalmente nuovi», serve
invece che emerga un «punto d’articolazione» nuovo, attorno al quale
tutti gli altri possano ricomporsi diversamente, formando un’inedita
configurazione popolare. In breve, serve un discorso di nuova
emancipazione e un soggetto credibile che la incarni. Ancora una volta,
su questo aspetto specifico, la declinazione sovranista del populismo
democratico dimostra di essere subalterna al discorso dell’avversario,
dando per consolidati e stabili il panorama politico, il tipo di
articolazione raggiunta dai gruppi sociali e le richieste che questi
formulano. Il momento populista è invece caratterizzato da movimenti
continui, scomposizioni e ricomposizioni di forze, creazione rapida di
nuove identità e bisogni. Questo non vuol dire che non ci sarà in futuro
una fase di stabilizzazione, ma che gli assetti su cui questa fase si
stabilizzerà vengono decisi ora, nel momento populista, da chi riesce a
costruire i soggetti più credibili, da chi sa politicizzare le faglie
giuste, da chi ha più immaginazione e coraggio politico, perché non c’è
cosa più sbagliata e codarda di fare il populismo con il popolo degli
altri.