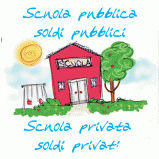Il nostro Paese è in caduta libera. Non è certo un
mistero, tutti lo sanno, tutti ne parlano: istituzioni, società civile,
comune opinione. Accendi la radio e senti il direttore centrale
dell’Istat dichiarare che, accanto ai dati drammatici sull’aumento della
povertà “assoluta”, negli ultimi due anni sono raddoppiate le famiglie
“in grave difficoltà”, quelle che secondo i parametri europei rispondono
a caratteristiche come le seguenti: neanche una settimana l’anno di
vacanza, niente carne o pesce ogni due giorni, riduzione dell’erogazione
di riscaldamento, non disponibilità di 800 euro per spese improvvise; e
via di questo passo. Il 17% delle famiglie italiane (otto milioni di
persone) poco sopra la soglia di povertà: un imprevisto sfavorevole e
precipiti anche tu verso il fondo. Accendi il televisore e apprendi da
un lavoratore dell’Alcoa che, in quello specifico contesto di crisi, dal
gennaio ad oggi si sono registrati 40 (quaranta!) suicidi. Storie
ordinarie di una straordinaria crisi capitalistica. Non stupisce che vi
sia (vedi il cinquestellare Casaleggio e il ministro della Repubblica
Delrio) chi profetizza che alla ripresa settembrina dell’anno politico
possano verificarsi delle esplosioni di rabbia sociale. Né può
sorprendere la previsione (solo apparentemente opposta) che “una
situazione di alta disoccupazione possa essere accettata come la nuova
normalità” e che “la gente possa accettare una depressione più o meno
permanente, finendo per pensare che è così che vanno le cose” (Krugman).
Quale potrà essere la piega degli eventi dipenderà in molta parte
dall’esistenza o meno di una radicale, compatta, convincente opposizione
allo stato di cose presente. Un’opposizione che, in ogni caso, deve
aver chiaro ciò a cui si contrappone: non semplici errori di questo o
quel governo, dettati da visuale corta e/o teorie economiche fasulle; ma
la consapevole gestione di un passaggio d’epoca, una generale e
strutturale involuzione (sociale e istituzionale) a tutto svantaggio
delle classi subalterne.
Non si capirebbe altrimenti la pervicacia,
apparentemente paradossale, con cui – in Italia come in Europa – si
insiste nel (cosiddetto) errore. La dura realtà dei fatti ha smentito il
mantra neoliberista: decretando che l’austerità deprime
l’economia e ammazza la crescita. Si tratta di una delle più clamorose
falsificazioni empiriche nella storia del pensiero economico. Eppure,
ancora qualche giorno fa, Peter Praet, capo economista e membro del board
della Bce, raccomandava di non abbassare la guardia sul terreno del
consolidamento dei conti pubblici e dei tagli alla spesa: certo, per
l’Italia egli suggerisce di migliorare “la qualità” delle scelte, visto
l’esito infausto di quelle già adottate; ma la linea del rigore non va
abbandonata, perché non è possibile escludere “un riacutizzarsi delle
tensioni nei mercati”. La minaccia dello spread è insomma sempre
dietro l’angolo. Poco importa che ripetute analisi (da ultimo, quella
degli economisti Paul de Grauwe e Yuemei Ji) dimostrino l’insussistenza
di una correlazione tra l’andamento dello spread e i conti pubblici (in particolare, il debito) e, viceversa, confermino un forte collegamento tra lo spread
medesimo e la solidità della costruzione europea (e dell’euro) in
quanto tale. Tant’è che è bastato l’annuncio nello scorso luglio 2012 di
una garanzia assicurata dalla Bce ai Paesi Ue più esposti alla crisi,
per raffreddare la tensione attorno a tale parametro. Né vale reiterare
l’essenziale considerazione che la spesa pubblica italiana non è affatto
superiore alla media europea; ed anzi risulta più bassa, laddove si
scorporino gli interessi sul debito (impennatisi dal 1981, cioè da
quando il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro ha esentato la prima
dall’acquisto di titoli pubblici e costretto il secondo ad attrarre, con
alti interessi, gli acquirenti privati nel mercato aperto). Non di
ulteriori tagli di spesa avrebbe bisogno il bilancio del nostro Stato,
quanto ad esempio di incrementare le entrate con l’abbattimento
(finalmente!) dell’evasione e dell’elusione fiscale, oltre che
attraverso una revisione del prelievo fiscale in senso fortemente
progressivo. Ma, se non bastassero i rilievi di keynesiani e pericolosi
marxisti, dovrebbe almeno far riflettere l’impietosa bocciatura
sanzionata dalla Corte dei Conti in occasione della cerimonia di
parificazione dei conti dello Stato, alla fine dello scorso giugno: le
manovre lacrime e sangue hanno “depresso” l’economia italiana; e la
politica dei tagli di spesa lineari si è rivelata un fallimento,
causando una caduta verticale dei servizi.
Ancorché pressata dall’imperativo della crescita, la linea
dell’Eurozona resta appesa alle inequivoche parole pronunciate
recentemente da Angela Merkel davanti al Bundestag (la Camera bassa
tedesca): “Crescita e consolidamento del bilancio non sono in
contraddizione. Al contrario, si determinano a vicenda. In Germania
abbiamo dimostrato come si fa”. In effetti, non si tratta affatto di
un’inattingibile quadratura del cerchio.“Come si fa” la Germania lo ha
mostrato praticandolo su se stessa (con le “riforme” varate a partire
dal 2002 sotto il governo Schroeder dallo Hartz Committee: moderazione
salariale, razionalizzazione/flessibilità del mercato del lavoro,
ridimensionamento delle spese di welfare,
liberalizzazione/privatizzazione dei servizi); e poi imponendo tale
impostazione al resto d’Europa. Solo applicando rigorosamente questa
cura da cavallo (tradotto: un’inflessibile politica di classe), i Paesi
della periferia europea potranno forse ottenere qualche deroga sul piano
del conteggio del deficit e della tempistica nel rientro dal debito.
Mario Draghi, impegnato a mitigare il rigore teutonico, non
contravviene tuttavia alla logica di fondo. E’ di questi giorni la
notizia che, per favorire il credito bancario alla piccola e media
impresa (Pmi, che com’è noto caratterizza eminentemente il tessuto
produttivo di Paesi come l’Italia), la Bce allargherà la gamma di titoli
che le banche sono tenute a presentare come garanzia per ottenere
liquidità dalla Bce stessa, includendovi titoli cartolarizzati (i
famigerati Abs), basati appunto su prestiti alle Pmi. Ciononostante,
sarà assai difficile che tale misura interrompa la stretta creditizia:
come Draghi sa perfettamente, se tale stretta è in corso non è solo per
una carenza di offerta da parte delle banche ma anche per la carenza di
richieste da parte del mondo imprenditoriale, restio a rischiare
investimenti in tempo di crisi. E’ il solito giro vizioso: la gente non
consuma perché ha sempre meno soldi in tasca, le aziende non vendono e
(nel migliore dei casi) restringono l’attività (nel peggiore, chiudono).
E’ la selezione naturale innescata dalla crisi capitalistica, che ad
oggi vede soccombere, assieme alla parte più fragile dell’apparato
produttivo, il lavoro in quanto classe. Così è in Italia e in Europa;
così è negli Stati Uniti. Anche negli Usa infatti – come documenta Bruno
Cartosio nel suo La grande frattura – i ricchi stanno
combattendo la lotta di classe e stanno vincendo, mettendo a valore
“spostamenti decisivi nei rapporti di forza nella società”: “Tra il 1983
e il 2009, secondo l’Economic Policy Institute, poco meno del 92%
dell’incremento di ricchezza è andato al 10% più ricco; per il 30% della
fascia centrale l’incremento è stato pari al 15,5%, mentre il 60% più
povero si è impoverito del 7,5%”. Da tre decenni nel mondo è in atto
l’offensiva del potere capitalistico.
Entro un tale quadro va collocata e giudicata l’azione dei nostri
ultimi governi (inflessibilmente orientata dal ruolo di garanzia
presidenziale assunto e mantenuto oltre il consueto da Giorgio
Napolitano). Nel nostro caso, il conflitto di classe si intreccia con il
ruolo subalterno previsto per il nostro Paese nella competizione
sovranazionale tra capitali. Cosa avrebbe dovuto dire alla signora
Merkel un Presidente del Consiglio che non fosse Letta (ma neanche Renzi
o Alfano)? Poche cose ma chiare: Cara signora, con il Patto fiscale
(Fiscal compact) concordato in sede Ue e approvato nel luglio 2012 da un
Parlamento italiano in larga maggioranza sottomesso (e senza
comunisti), ci costringete a prelevare dalle tasche dei nostri cittadini
una cinquantina di miliardi all’anno per i prossimi 20 anni. In più,
contribuiamo al cosiddetto “Fondo salva stati” – che l’Europa mette a
disposizione degli Stati in difficoltà col vincolo del varo di misure
socialmente pesantissime – versando una quota parte del 18% del capitale
totale (125 miliardi di euro in cinque anni). Tutto ciò è incompatibile
con qualunque prospettiva di sviluppo socialmente e ambientalmente
progressivo. Chiediamo quindi una revisione dei Trattati; in caso di
rifiuto disubbidiremo ai Trattati stessi.
E’ grosso modo quello che ha detto Alexis Tzipras, leader di Syriza, a
proposito del memorandum capestro imposto alla Grecia. E’ quello che
dovrebbe dire un Presidente del Consiglio eletto da un cartello delle
sinistre in Italia. Purtroppo siamo dentro tutt’altra scena. Qualche
giorno fa Enrico Letta era a Londra presso l’ambasciata italiana che,
per l’occasione, riuniva il Gotha della City: presidenti delle grandi
banche di Wall Street, gestori dei grandi fondi d’investimento ecc. Le
cronache raccontano (vedi la Repubblica del 19 luglio scorso) che
un investitore ha alzato la mano e ha avanzato provocatoriamente la
seguente domanda: quand’è che vi arrendete all’evidenza, ristrutturate
il debito o applicate una patrimoniale? Risposta pronta di Letta:
nessuna ristrutturazione del debito e nessuna patrimoniale. A settembre o
ottobre – ha aggiunto – “lanceremo un piano di privatizzazioni” ed esso
riguarderà “anche le imprese pubbliche quotate in Borsa”. Era
precisamente ciò che quel pezzo ragguardevole di capitale transnazionale
voleva sentire da un capo del governo italiano ligio allo status quo
e ai “poteri forti”: Eni, Enel, Finmeccanica, municipalizzate; ma anche
(perché no?) patrimonio paesaggistico e artistico (in Italia è
concentrato il 60% di tutti i beni artistici e archeologici
dell’umanità). Tutto ciò fa gola al capitale globale, soprattutto se
messo a disposizione a prezzi di saldo dalle urgenze della crisi. E’
dunque questo il piatto forte che si sta preparando per il nostro Paese,
dopo l’antipasto già consumato dalle multinazionali francesi del lusso,
venute da Oltralpe a fare shopping (col tricolore bianco rosso e blu
che sventola su Bulgari, Gucci, Fendi, Bottega Veneta, Pucci, Acqua di
Parma; e ora anche su Cova, storica pasticceria di via Montenapoleone).
Eppure questo impresentabile centro-sinistra dovrebbe trarre
insegnamento dalle esperienze passate: non è vero che privatizzando si
risolve la questione del debito pubblico; è vero piuttosto che il debito
pubblico è usato come cuneo per favorire operazioni a tutto vantaggio
del profitto privato. Le grandi privatizzazioni degli anni 90 hanno
aggravato i problemi del Paese: smantellando settori produttivi di
eccellenza, indebolendo la capacità del settore pubblico di orientare le
politiche industriali con investimenti ad alta intensità tecnologica e
ad alta produttività. C’è da sorprendersi se i nostri ricercatori,
vincitori di fondi europei per progetti di ricerca, scelgono l’estero e
non l’Italia? Come si sa, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si
azzecca. Nel giugno del ’93 Carlo Azeglio Ciampi, proseguendo la
svendita del patrimonio pubblico iniziata con il suo predecessore
Giuliano Amato, nomina un Comitato di consulenza per le privatizzazioni.
A presiederlo c’è un certo Mario Draghi, uomo di Goldman Sachs. Oggi
presidente della Bce: a volte ritornano…
In tutta questa orribile storia, brilla un’assente: una sinistra
unita, che si proponga di costruire veri e consistenti argini a tale
deriva. Perché non cominciamo a unire i comunisti?