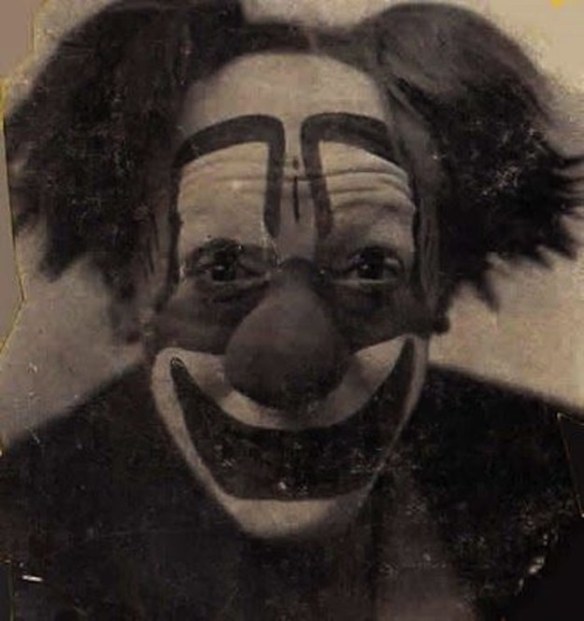 Scrive Luciano Gallino, uno dei più prestigiosi scienziati sociali del nostro Paese e fra i più stimati sostenitori di una radicale riforma del Finanzcapitalismo: «Dopotutto lo scopo sostanziale dell’economia consiste nel provvedere alla sussistenza dell’uomo al più alto livello possibile usando insieme con altri mezzi a esso subordinati – il lavoro, la terra, la conoscenza – anche lo strumento finanziario, il denaro» (1). Di Gallino mi sono occupato altre volte in passato, e sempre con un intento fortemente critico, polemico. Come mai? Niente di personale: le sue tesi costituiscono un ottimo esempio di quella concezione economica che Marx definì una volta volgare fino alla trivialità, cosa che mi permette di esternare qualche elementare concetto utile a combattere la stessa idea di un capitalismo a misura d’uomo.
Scrive Luciano Gallino, uno dei più prestigiosi scienziati sociali del nostro Paese e fra i più stimati sostenitori di una radicale riforma del Finanzcapitalismo: «Dopotutto lo scopo sostanziale dell’economia consiste nel provvedere alla sussistenza dell’uomo al più alto livello possibile usando insieme con altri mezzi a esso subordinati – il lavoro, la terra, la conoscenza – anche lo strumento finanziario, il denaro» (1). Di Gallino mi sono occupato altre volte in passato, e sempre con un intento fortemente critico, polemico. Come mai? Niente di personale: le sue tesi costituiscono un ottimo esempio di quella concezione economica che Marx definì una volta volgare fino alla trivialità, cosa che mi permette di esternare qualche elementare concetto utile a combattere la stessa idea di un capitalismo a misura d’uomo.
Infatti, cosa leggiamo nel passo sopra citato? In primo luogo un pensiero minimamente critico non può mancare di cogliere il carattere ingenuamente astratto del concetto di economia che vi compare, un concetto privo di quelle determinazioni storiche e sociali che sono le sole che possono riempirlo di reali, vitali e dinamici contenuti, togliendolo con ciò dal platonico mondo delle idee nel quale lo ha collocato Gallino. D’altra parte il nostro scienziato sociale non fa che muoversi lungo il percorso abbondantemente arato dall’economia borghese del XX secolo. Due nomi su tutti: Schumpeter e Keynes.
Scriveva ad esempio Schumpeter: «L’attività economica può avere qualsiasi motivazione ma il suo significato è sempre la soddisfazione dei bisogni. […] La produzione segue dunque i bisogni; è, per così dire, al loro rimorchio. La stessa cosa vale, mutatis mutandis, per l’economia di scambio. […] L’utilità regola in ultima istanza sia la produzione tecnica che quella economica» (2). Si noti anche qui la generalizzazione storico-sociale malamente impostata dall’economista austriaco.
Il capitalismo come economia dei bisogni è una vera e propria bestemmia, gridata non contro la faccia del comunista di Treviri, ma contro la verità della prassi capitalistica. Come anche un bambino può capire, sotto il regime capitalistico la produzione segue il profitto, è, per così dire, al suo rimorchio; essa ha necessariamente nella ricerca del massimo profitto il suo più verace significato e il suo più formidabile movente. È questa ricerca che «regola in ultima istanza sia la produzione tecnica che quella economica», come cercò di dimostrare Marx introducendo il fondamentale concetto di composizione organica del capitale.
Anche per Keynes, che Gallino vorrebbe attualizzare, «Ogni produzione ha lo scopo finale di soddisfare un consumatore. […] Per ripetere cose ovvie, il consumo è l’unico scopo e fine di tutta l’attività economica» (3). Al pensiero economico borghese appare insomma come ovvia una realtà presentata a testa in giù, capovolta cioè da un presupposto ideologico che non è capace di afferrare l’essenza della prassi economica in regime capitalistico.
Ora, si dà appunto il caso che l’economia dei nostri mercantilistici giorni, l’economia dominata dal rapporto sociale capitalistico (il Capitale che sfrutta il Lavoro con mezzi e metodi sempre più scientifici), non abbia come scopo essenziale quello di «provvedere alla sussistenza dell’uomo al più alto livello possibile», come pensa Gallino nella sua commovente ingenuità, bensì quello, forse meno “eticamente corretto” ma certamente più vero e necessario (posto il vigente status quo sociale), di generare profitti, «al più alto livello possibile» e nel modo più rapido e facile possibile. È il capitalismo (tout court, senza altre inutili e forvianti aggettivazioni), bellezza! E nel capitalismo la soddisfazione dei bisogni ha un carattere puramente strumentale, è cioè subordinata alla soddisfazione dei bisogni che fanno capo all’investimento capitalistico: per dirla nei consueti termini marxiani, il valore di scambio delle merci domina necessariamente sul loro valore d’uso (4).
Questo disumano dominio ha un esempio particolarmente pregnante nella distruzione su vasta scala delle materie prime alimentari (vegetali e animali) che lo Stato degli Stati Uniti organizzò nei primi anni Trenta nel tentativo di frenare il crollo dei prezzi di quelle materie prime. E questo mentre milioni di persone morivano letteralmente di fame. «Agli agricoltori americani il credito fu esteso in cambio della riduzione della produzione. Ed è strano parlare di sovraproduzione quando, di fatto, il cibo è negato ad una popolazione più che disposta a consumarla. Eppure, derrate alimentari di ogni genere venivano gettate via e coperte di calce viva e tossico per impedire agli affamati di servirsene» (5). La fame di profitti ebbe insomma la meglio sulla fame degli uomini, com’è necessario che accada sulla base del capitalismo. Come sempre, il cinismo delle parole non fa che esprimere il cinismo della cosa.
A ben vedere, tutto il gran parlare di deflazione oggi non ha altro significato che quello appena evocato.
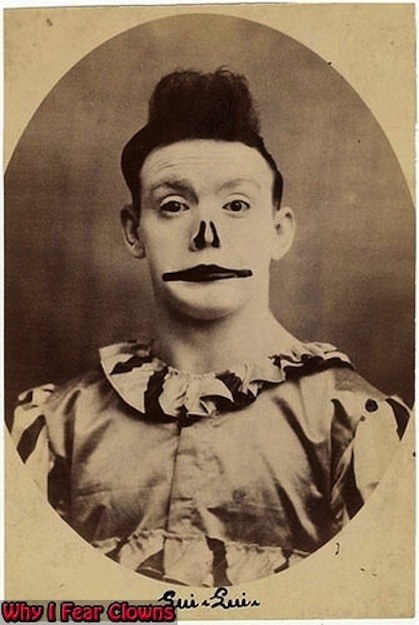 Scrive Gallino a proposito dell’«investimento irresponsabile» dei risparmi: «L’effetto perverso deriva dal fatto che nel tutelare gli interessi dei risparmiatori gli investitori istituzionali sono del tutto indifferenti alla natura e alle conseguenze degli investimenti che effettuano con i soldi degli altri. L’unico criterio che li guida è la massimizzazione del rendimento del capitale investito – preferibilmente a breve termine» (p.19). Insomma, Gallino bolla come «perverso» ciò che invece rappresenta la normalità, il solo criterio naturale che orienta qualsiasi investitore sulla base dell’economia fondata sul profitto. Come sempre il riformatore sociale dell’«economia mondo» (leggi capitalismo) respinge i “lati cattivi” di questo regime sociale, senza metterne in discussione i presunti “lati positivi”. Ecco perché le sue tirate contro «il lavoro mercificato» e «le tecnologie usate contro l’intelligenza» appaiono non più che impotenti lamentele. Miseria del riformismo sociale, avrebbe detto l’uomo con la barba.
Scrive Gallino a proposito dell’«investimento irresponsabile» dei risparmi: «L’effetto perverso deriva dal fatto che nel tutelare gli interessi dei risparmiatori gli investitori istituzionali sono del tutto indifferenti alla natura e alle conseguenze degli investimenti che effettuano con i soldi degli altri. L’unico criterio che li guida è la massimizzazione del rendimento del capitale investito – preferibilmente a breve termine» (p.19). Insomma, Gallino bolla come «perverso» ciò che invece rappresenta la normalità, il solo criterio naturale che orienta qualsiasi investitore sulla base dell’economia fondata sul profitto. Come sempre il riformatore sociale dell’«economia mondo» (leggi capitalismo) respinge i “lati cattivi” di questo regime sociale, senza metterne in discussione i presunti “lati positivi”. Ecco perché le sue tirate contro «il lavoro mercificato» e «le tecnologie usate contro l’intelligenza» appaiono non più che impotenti lamentele. Miseria del riformismo sociale, avrebbe detto l’uomo con la barba.
«Per quasi una generazione si è affermata la credenza e una prassi per cui qualità e quantità della sussistenza, scalzata dalla sua posizione di scopo ultimo [sic!], potevano derivare soltanto dall’ascesa al potere della finanza» (p. 16). A quando Gallino data questo maligno capovolgimento di paradigma? Bisogna risalire alla «de-regolamentazione dei mercati finanziari e dell’ambito di attività delle banche che è partita dagli Stati Uniti nel 1974. […] Il sistema finanziario mondiale ha subito una trasformazione da strumento dell’economia reale a suo padrone» (p. 17). Intanto, già il vegliardo autore del Capitale ebbe modo di osservare in Inghilterra la sempre più spinta “finanziarizzazione” dell’economia, che egli interpretò come necessaria conseguenza dello sviluppo capitalistico, del farsi potenza sociale del Capitale. Sviluppo delle funzioni del credito, formazione di sempre più grandi società per azioni: per Marx si tratta dell’annullamento del carattere privato dell’iniziativa economica capitalistica «sulla base del sistema capitalistico stesso» (6). Per non parlare poi di chi già agli inizi del XX secolo individuò proprio nel dominio del capitale finanziario la caratteristica saliente del capitalismo giunto nella sua piena maturità: vedi L’imperialismo di J. A. Hobson (1902), il Capitale finanziario di R. Hilferding (1909) e l’Imperialismo di Lenin (1916).
Contrapporre la finanza (compresa quella speculativa) all’economia reale, come fa Gallino (in eccellente e numerosa compagnia, peraltro), significa non aver compreso almeno l’ultimo secolo di sviluppo capitalistico. Partendo da questi presupposti concettuali anche la crisi finanziaria americana del 2007, lungamente preparata dentro l’economia reale (per reagire al declino del saggio del profitto, per allargare sempre di nuovo le occasioni di investimento profittevole, ecc.), deve apparire sostanzialmente come il prodotto di scelte sbagliate in materia di politica economica. Né può avere una corretta interpretazione l’attuale conflitto sistemico che scuote dalle fondamenta l’Unione europea, spiegato sostanzialmente come il frutto di un rapido svuotamento della democrazia volto a «proseguire con ogni mezzo la redistribuzione del reddito, della ricchezza e del potere politico dal basso verso l’alto in corso da oltre trent’anni» (7).
È invece vero che all’inizio degli anni Settanta, quando apparve fin troppo chiaro che il lungo e poderoso ciclo economico espansivo seguito alla Seconda guerra mondiale si era chiuso definitivamente, nel capitalismo avanzato si posero tre problemi di grande portata e strettamente connessi l’uno all’altro. Vediamoli in brevissima sintesi e senza la pretesa di aver con ciò esaurito la gamma dei problemi in gioco.
1) Come adeguare la struttura finanziaria venuta fuori a Bretton Wood nel ’44 ai profondi mutamenti intervenuti nel frattempo nell’economia mondiale (“reale” e “finanziaria”) e ai nuovi equilibri politici ed economici fra i Paesi capitalisticamente più forti del pianeta: Stati Uniti, Germania e Giappone, in primis.
2) Come dare soddisfazione (“sfogo”) alla massa dei capitali che, non trovando più remunerativo l’investimento produttivo primario (industriale), iniziò a premere sulla sfera dei servizi (inclusi quelli finanziari) in cerca di più allettanti rendimenti. Trattasi della marxiana sovraccumulazione, o eccesso, ovvero pletora di capitale, fenomeno che si realizza appunto quando la profittabilità dell’investimento produttivo declina, come accadde nelle metropoli capitalistiche ben prima che esplodesse la crisi finanziaria degli anni Settanta.
3) Come riformare il welfare e il rapporto Stato-mercato sorti come risposta alla Grande Crisi del ’29 ed entrati in crisi con la nuova fase storica del capitalismo internazionale. La dottrina dell’«aggiustamento strutturale» di Milton Friedman e di Edmund Phelps non spiega la crisi dell’ortodossia keynesiana, ma quest’ultima spiega semmai la prima, la quale ha il fondamento oggettivo che ho cercato di abbozzare.
Come ho scritto altre volte, se non si tengono presenti questi processi strutturali la famigerata «controrivoluzione neoliberista» che porta i nomi della Thatcher e di Reagan appare come un fatto deciso sostanzialmente in sede politica dalla classe dominante per schiacciare un proletariato diventato troppo forte. Una lettura dei fatti fin troppo ideologica, tesa soprattutto a incensare la sinistra politica e sindacale attiva nei trent’anni d’oro dell’accumulazione capitalistica postbellica.
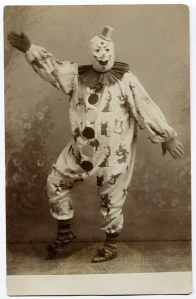 «Per una società che voglia fondarsi su una concezione oggettiva piuttosto che strumentale di ragione – la ragione che riguarda, come scriveva Max Horkheimer, non il mero calcolo del rapporto tra mezzi e fini, bensì l’ideale del massimo bene, il problema del destino umano, il modo di realizzare i fini ultimi – non appare sostenibile il tipo di essere umano, ovvero di personalità o di carattere, che l’economia contemporanea è orientata a produrre» (pp. 191-192). Di qui, per Gallino, la necessità di abbandonare l’economia basata sugli «investimenti irresponsabili» (egli è anche l’autore dell’Impresa irresponsabile) per orientarsi verso un’economia centrata sugli «investimenti responsabili», ossia sugli investimenti tesi a sviluppare la produzione dei «beni pubblici» (scuola, trasporti, sanità) e a finanziare attività produttive ecosostenibili. Questo progetto riformista dovrebbe ottenere il sostegno di una finanza ricondotta finalmente alla sua originaria funzione di ancella dell’economia reale. Come tutti i riformatori del capitalismo, da Proudhon in poi, Gallino sconosce la natura del denaro in regime capitalistico, e difatti esso gli appare non come l’espressione di un peculiare rapporto sociale, non come il risultato (storico, logico e sociale) di un processo che inizia con lo sfruttamento del lavoro (vedi il concetto marxiano di lavoro astratto o sociale, fondamento del valore di scambio e quindi del denaro), ma appunto come strumento funzionale alla cosiddetta economia reale. Insomma, il denaro come cosa, come tecnologia economica, secondo il fenomeno feticista a suo tempo magistralmente illuminato dal noto psicoanalista della merce. Che tutte le magagne economiche, sociali ed esistenziali lamentate nei numerosi libri di Gallino hanno come loro fondamento la tanta celebrata «economia reale», ebbene questo fatto risulta del tutto incomprensibile alla coscienza del nostro scienziato sociale. In regime capitalistico, l’impresa socialmente responsabile è quella orientata al massimo profitto, per conseguire il quale essa non deve farsi scrupoli di sorta dinanzi alla necessità di licenziare i lavoratori «in esubero».
«Per una società che voglia fondarsi su una concezione oggettiva piuttosto che strumentale di ragione – la ragione che riguarda, come scriveva Max Horkheimer, non il mero calcolo del rapporto tra mezzi e fini, bensì l’ideale del massimo bene, il problema del destino umano, il modo di realizzare i fini ultimi – non appare sostenibile il tipo di essere umano, ovvero di personalità o di carattere, che l’economia contemporanea è orientata a produrre» (pp. 191-192). Di qui, per Gallino, la necessità di abbandonare l’economia basata sugli «investimenti irresponsabili» (egli è anche l’autore dell’Impresa irresponsabile) per orientarsi verso un’economia centrata sugli «investimenti responsabili», ossia sugli investimenti tesi a sviluppare la produzione dei «beni pubblici» (scuola, trasporti, sanità) e a finanziare attività produttive ecosostenibili. Questo progetto riformista dovrebbe ottenere il sostegno di una finanza ricondotta finalmente alla sua originaria funzione di ancella dell’economia reale. Come tutti i riformatori del capitalismo, da Proudhon in poi, Gallino sconosce la natura del denaro in regime capitalistico, e difatti esso gli appare non come l’espressione di un peculiare rapporto sociale, non come il risultato (storico, logico e sociale) di un processo che inizia con lo sfruttamento del lavoro (vedi il concetto marxiano di lavoro astratto o sociale, fondamento del valore di scambio e quindi del denaro), ma appunto come strumento funzionale alla cosiddetta economia reale. Insomma, il denaro come cosa, come tecnologia economica, secondo il fenomeno feticista a suo tempo magistralmente illuminato dal noto psicoanalista della merce. Che tutte le magagne economiche, sociali ed esistenziali lamentate nei numerosi libri di Gallino hanno come loro fondamento la tanta celebrata «economia reale», ebbene questo fatto risulta del tutto incomprensibile alla coscienza del nostro scienziato sociale. In regime capitalistico, l’impresa socialmente responsabile è quella orientata al massimo profitto, per conseguire il quale essa non deve farsi scrupoli di sorta dinanzi alla necessità di licenziare i lavoratori «in esubero».
«La ragione – scriveva Max Horkheimer – è ormai completamente aggiogata al processo sociale; unico criterio è diventato il suo valore strumentale, la sua funzione di mezzo per dominare gli uomini e la natura. […] Ora che la scienza ci ha aiutati a vincere il terrore dell’ignoto nella natura siamo schiavi di pressioni sociali che noi stessi abbiamo create» (8). Di qui, l’urgente necessità, per chi scrive, di superare alla radice il processo sociale capitalistico. Un’urgenza che purtroppo oggi non trova una “base di massa” su cui fare leva, per così dire. Cosa che d’altra parte non la fa apparire meno vera, almeno da quello che definisco punto di vista umano. Parlare di «ideale del massimo bene», del «problema del destino umano» e di «fini ultimi» sul fondamento della vigente «economia mondo», magari riformata nel senso auspicato da Gallino (più che di un’utopia si tratta di una chimera), significa fare dell’ideologia e sostenere “da sinistra” lo status quo sociale.
(1) L. Gallino, Con i soldi degli altri, pp. 5-6, Einaudi, 2009.
(2) J. A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, pp. 9-10, Sansoni, 1971.
(3) J. M. Keynes, Teoria generale, pp. 204-264, UTET, 1978.
(4) «L’estensione o la riduzione della produzione non viene decisa in base al rapporto fra la produzione ed i bisogni sociali, i bisogni di un’umanità socialmente sviluppata, ma in base all’appropriazione del lavoro non pagato [base oggettiva del plusvalore] ed al rapporto fra questo lavoro non pagato ed il lavoro oggettivato in generale o, per usare un’espressione capitalistica, in base al profitto ed al rapporto fra questo profitto ed il capitale impiegato, vale a dire in base al livello del saggio del profitto» (K. Marx, Il Capitale, III, p. 312, Editori Riuniti, 1980).
(5) P. Mattick, La grande crisi e il New Deal, in Due secoli di Capitalismo USA, autori vari, p. 243, Dedalo, 1980.
(6) Vedi il capitolo 27, libro terzo del Capitale.
(7) Vedi L. Gallino, Il colpo di Stato di banche e governi, Einaudi, 2013.
(8) M. Horkheimer, Eclisse della ragione, pp. 25-160, Einaudi, 2000.
(2) J. A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, pp. 9-10, Sansoni, 1971.
(3) J. M. Keynes, Teoria generale, pp. 204-264, UTET, 1978.
(4) «L’estensione o la riduzione della produzione non viene decisa in base al rapporto fra la produzione ed i bisogni sociali, i bisogni di un’umanità socialmente sviluppata, ma in base all’appropriazione del lavoro non pagato [base oggettiva del plusvalore] ed al rapporto fra questo lavoro non pagato ed il lavoro oggettivato in generale o, per usare un’espressione capitalistica, in base al profitto ed al rapporto fra questo profitto ed il capitale impiegato, vale a dire in base al livello del saggio del profitto» (K. Marx, Il Capitale, III, p. 312, Editori Riuniti, 1980).
(5) P. Mattick, La grande crisi e il New Deal, in Due secoli di Capitalismo USA, autori vari, p. 243, Dedalo, 1980.
(6) Vedi il capitolo 27, libro terzo del Capitale.
(7) Vedi L. Gallino, Il colpo di Stato di banche e governi, Einaudi, 2013.
(8) M. Horkheimer, Eclisse della ragione, pp. 25-160, Einaudi, 2000.

Nessun commento:
Posta un commento
Di la tua