L’esistenza del denaro presuppone la reificazione del contesto sociale (1).
Dove c’è la moneta, insiste sempre e necessariamente un rapporto sociale di dominio e di sfruttamento.
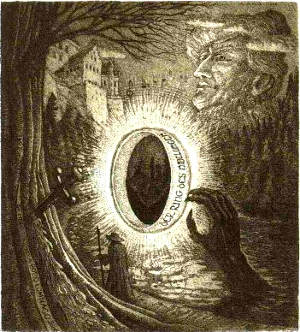 Alla ricerca, in precario equilibrio tra il chimerico e il comico,
di «una moneta del comune come possibile embrione della costruzione di
un circuito finanziario alternativo, che sfugga al controllo e alle
imposizioni delle oligarchie finanziarie», il comunardo Andrea Fumagalli
fa una serie di scoperte davvero sorprendenti. Egli scopre ad esempio
che «la moneta è un’invenzione umana [che] non cresce sugli alberi»,
che essa «ci dimostra che l’essere umano è un animale sociale» (2). Non
ditemi che queste cose le aveva già scoperte non pochi secoli fa un
antico filosofo greco perché non ci credo! Lasciamo cadere ogni invidia,
e seguiamo con fiducia Fumagalli lungo la via che mena al
Comun(e)ismo. «Comun(e) che?». Insomma, abbiate fede!
Alla ricerca, in precario equilibrio tra il chimerico e il comico,
di «una moneta del comune come possibile embrione della costruzione di
un circuito finanziario alternativo, che sfugga al controllo e alle
imposizioni delle oligarchie finanziarie», il comunardo Andrea Fumagalli
fa una serie di scoperte davvero sorprendenti. Egli scopre ad esempio
che «la moneta è un’invenzione umana [che] non cresce sugli alberi»,
che essa «ci dimostra che l’essere umano è un animale sociale» (2). Non
ditemi che queste cose le aveva già scoperte non pochi secoli fa un
antico filosofo greco perché non ci credo! Lasciamo cadere ogni invidia,
e seguiamo con fiducia Fumagalli lungo la via che mena al
Comun(e)ismo. «Comun(e) che?». Insomma, abbiate fede!
Vediamo dunque con animo aperto alla speranza le altre perle nel sacco del nostro amico:
«La
moneta è relazione sociale [e qui mi tolgo il cappello in segno di
approvazione]. Una relazione sociale che oggi non è paritaria, ma che
potrebbe diventarlo [qui invece inizio a nicchiare]. La moneta è la
dimostrazione dell’esistenza di una comunità, perché la moneta è frutto
di un rapporto di fiducia».
Prescindendo da ogni altra considerazione
critica volta a mettere in discussione il quadro abbastanza confuso
appena visto, mi chiedo: una relazione sociale «paritaria» non
presuppone la scomparsa della moneta? Vediamo come risponde il Nostro:
«La moneta è, soprattutto, potere. Potere di decisione, potere di
arbitrio. E oggi è potere capitalistico. Per questo la moneta non è un
bene comune». Se ho bene inteso, oggi la moneta «è potere capitalistico», mentre domani essa potrebbe esprimere un ben diverso potere, e precisamente quello comunardo.
Ho capito bene? «Nell’attuale bio-capitalismo cognitivo e
finanziarizzato, se una lotta deve esserci essa dovrà necessariamente
essere la lotta per la moneta intesa come common. È lotta per il “comun(e)ismo”». Ho capito bene: più che di chimera si tratta di farsa! Comun(e)ismo:
ma quanto sono astuti e creativi questi post-marxisti!! Basta in
qualche modo alludere allo scandaloso marchio di fabbrica del bel tempo
che fu, e il gioco salottiero è fatto, e la coscienza comunarda è a
posto. Comun(e)ismo: ma mi faccia il piacere! Mi rendo conto: qui
la mia estrazione sociale proletaria fa premio sulla pacata
riflessione scientifica. D’altra parte, è difficile conservare un certo
distacco intellettuale dinanzi alle astruserie dottrinarie e
terminologiche dei teorici del «bio-capitalismo cognitivo e
finanziarizzato» .
Per sdoganare il concetto di moneta “comun(e)ista”, Fumagalli
proietta la cacca capitalistica persino sulla preistoria: «La moneta ha
svolto diverse funzioni nella storia dell’umanità. Esiste da subito,
come il fuoco, la ruota, la scoperta dell’agricoltura. Nelle società
preistoriche è mezzo di scambio e unità di conto. Mezzo di pagamento per
consentire la relazione sociale dettata dall’attività di scambio per
la sopravvivenza: la necessità del neg-otium (la dannazione del labor), in opposizione all’otium
(il piacere della creatività e dell’ingegno umano). E in quanto tale,
unità di misura del valore delle merci scambiate. La moneta è quindi da
subito rappresentazione fenomenica del valore».
Da subito? E che fine
ha fatto la lunga epoca basata sul baratto? Non ha forse il baratto
preceduto lo scambio dei prodotti mediato dalla moneta? E a sua volta il
baratto non ha alle spalle una lunga prassi comunitaria basata su una
produzione di mera sussistenza che escludeva qualsiasi forma di scambio
basata sul valore-lavoro dei prodotti? (3)
È vero che la moneta è, come la merce e il prezzo, una categoria
economica «antidiluviana», ma rimane sempre il fatto che essa ha avuto
una lunga genesi storica il cui presupposto essenziale va rintracciato
nella struttura di classe che minò l’antica comunità, la quale per un
lunghissimo tempo non ebbe alcun bisogno della moneta per regolare lo
scambio di prodotti al suo interno. Per questo possiamo individuare
caratteristiche comuni tra i modi di produzione basati sullo
sfruttamento classista degli individui. Sto forse idealizzando il
«comunismo primitivo»? Lungi da me. Sto semplicemente affermando una
verità che non dovrebbe sfuggire ai luminari della Scienza. «Ciò che
Adam Smith, alla maniera tipica del XVIII secolo, pone nel periodo
preistorico e fa precedere alla storia, è piuttosto il suo prodotto»
(4). D’altra parte, lo stesso Fumagalli si riferisce alla fine del
baratto come «alla fase della nascita della moneta».
Piccola digressione (?). Com’è noto, gli economisti di scuola
stalinista si richiamavano proprio alle «categorie antidiluviane» che
precedettero la nascita del Capitalismo per giustificare l’esistenza nel
cosiddetto «socialismo reale» delle forme economiche tipiche del
capitalismo: merce, denaro, lavoro salariato e via di seguito. Se nelle
società precapitalistiche riscontriamo le note «categorie
antidiluviane», perché esse non dovrebbero persistere nella società
post-capitalistica, nel socialismo? Con questa stringente logica
dialettica (sic!), veniva celato l’elemento classista che
accomuna le società che hanno conosciuto l’economia monetaria. A questi
economisti era sufficiente appiccicare alla merce, al denaro, al
mercato ecc. l’etichetta socialista, per far svanire magicamente
la realtà di un miserabile Capitalismo a forte vocazione imperialista.
Avanzo un antipatico dubbio: non è che i teorici del Comun(e)ismo
hanno in testa un analogo rituale magico?
Dalla triviale quanto apologetica (l’economia monetaria come
economia essenzialmente umana, come prassi connessa alla nostra stessa
“dimensione antropologica”) considerazione sopracitata, viene a galla
la concezione feticistica della moneta di Fumagalli: la moneta come
tecnologia in sé socialmente neutra (checché ne dica il nostro), la
quale può servire tanto cattive quanto buone prassi. E difatti egli
scrive che «La cripto-moneta, come qualsiasi tipo di moneta, è uno
strumento. E, come ogni strumento, la sua utilità dipende dal modo e dal
contesto sociale in cui viene utilizzata. Come scriveva Keynes, la
moneta è un ponte che collega il presente al futuro». Sulla
«cripto-moneta» ritorneremo tra poco. Già l’evocazione di Keynes in un
contesto concettuale che ha la moneta come principale oggetto d’indagine
è, come si dice, tutto un programma.
È appena il caso di ricordare che per Marx «la moneta è il denaro
posto nella sua forma di mezzo di circolazione», è il mezzo materiale
con cui si manifesta la ricchezza astratta, ossia sociale, la quale
presuppone e pone sempre di nuovo peculiari rapporti sociali di dominio e
di sfruttamento. Volere aggirare questa scottante verità «con
acciarpature monetarie», per mutuare la critica marxiana del
denaro-lavoro di Proudhon e Owen, è semplicemente ridicolo.
L’economia monetaria borghese presuppone la forma salariata del
lavoro, e Marx rimproverò a Ricardo di «non comprendere la connessione
esistente fra questo lavoro e il denaro, né la necessità che il lavoro
si rappresenti come denaro, [né] la necessità delle merci di procedere
alla formazione di denaro. Donde la sua falsa teoria del denaro» (5).
Gratta la moneta, qualsivoglia natura essa abbia (materiale o
immateriale, cartaceo o elettronica), e trovi puntualmente e
necessariamente sotto un velo di apparente neutralità il maligno lavoro
salariato, ossia il mondo borghese delle merci – materiali e
immateriali, inorganiche e umane. «L’esistenza sociale del lavoro appare come l’esistenza monetaria della merce» (6). Ecco perché la moneta, anche quella finanziaria
dei nostri giorni che «non a caso coincide con la dematerializzazione
totale del denaro», non è mai un puro segno, come crede Fumagalli,
proprio perché il suo presupposto mediato, che va ricostruito
dialetticamente gettando l’occhio al di là dei molti veli che rendono di
non immediata comprensione l’essenza della cosa, rimane sempre il
rapporto sociale capitalistico. Se il denaro, sempre colto nelle sue
diverse e contraddittorie determinazioni, ha una «qualità sociale, esso
può averla solo perché gli individui hanno alienato, sotto forma di
oggetto, la loro propria relazione sociale» (7).
Qui non è la natura di questo oggetto quel che conta, ma la natura
del rapporto sociale dominante nell’epoca della sussunzione globale,
planetaria e totalitaria degli individui al Capitale. A quanto pare, più
il denaro si «dematerializza», assecondando peraltro l’intima natura
di una potenza sociale che si nutre di profitto e che per conseguirlo
inventa sempre nuove – e assai spesso chimeriche – occasioni di
profitto; e più il pensiero della scienza economica 2.0 si reifica,
rimanendo in tal modo impigliata nel mondo delle pure apparenze.
Il
denaro, ci fa sapere Marx, «è soltanto un segno nella circolazione,
nella quale il denaro ha un’esistenza contrapposta a quella delle
merci», ma «nella sua determinazione di misura, invece, il suo sostrato
materiale [è] essenziale» (8). Se l’ubriacone tedesco non fosse andato a
lezione da Hegel, cosa che peraltro certi “marxisti” scientisti non
mancheranno di rimproverargli, difficilmente egli avrebbe avuto ragione
della complessa dialettica delle cose.
Visti i presupposti teorici da cui muove, non sorprende come la
stessa ricostruzione storica abbozzata da Fumagalli per seguire i
cambiamenti di funzione della moneta nel corso dei millenni e
soprattutto in ambito capitalistico (dalla moneta mezzo di pagamento
alla moneta creditizia ecc.) appaia viziata in radice. Naturalmente
anche Fumagalli ha letto Marx, e quindi sa meglio di chi scrive che «Con
l’avvento del sistema di produzione capitalista, la moneta diventa
espressione del capitale e del rapporto sociale di sfruttamento del
lavoro». Tuttavia, egli non riesce a comprendere l’essenza del processo
sociale (il passaggio dal “vecchio” Capitalismo dominato dal capitale
industriale al “nuovo” Capitalismo sempre più dominato dal capitale
finanziario) che pure descrive con un’invidiabile accuratezza tecnica.
Viceversa, a Fumagalli non passerebbe nemmeno per l’anticamera del
cervello la bizzarra, per non dire altro, idea di poter «portare l’attacco al cuore dei mercati finanziari»
rimanendo sullo stesso terreno di un’economia monetaria, sebbene
“alternativa” e parallela a quella “ufficiale” fondata sul profitto.
Come ho scritto altre volte, i teorici del bio-capitalismo cognitivo
immaginano la Rivoluzione sociale del futuro secondo il modello offerto
dalla Rivoluzione borghese, la quale giunse alla ribalta della storia
quando l’economia dei moderni ceti borghesi si era già sufficientemente
consolidata nell’ambito di un regime sociale che ne soffocava
l’ulteriore sviluppo, impedendo che i nuovi rapporti sociali
informassero l’intera prassi sociale.
«Portare l’attacco al cuore dello Stato, pardon, dei mercati finanziari»:
questa frase che vuole essere ironica e forse persino evocativa in
realtà ci dice due cose molto precise intorno a chi l’ha scritta. In
primo luogo ci parla della sua indigenza teorica e politica per ciò che
concerne la natura del processo sociale capitalistico, il quale non
ammette l’esistenza di un solo atomo di economia
“alternativa/parallela”; e in secondo luogo ci dice che i cosiddetti
“cattivi maestri” degli anni Settanta, quelli che blateravano di una
“rivoluzione proletaria” che si sviluppava solo nelle loro
intellettualistiche teste, non hanno ancora smesso di giocare alla
“rivoluzione”. Certo, oggi il loro linguaggio è meno “sovversivo” e
presta più il fianco all’interesse di qualche banchiere eticamente
motivato che alla repressione poliziesca.
Per una bizzarria del pensiero che andrebbe indagata più a fondo, i
teorici del bio-capitalismo cognitivo osservano una contraddizione in
grado di far sviluppare forme economiche alternative incompatibili con
lo sfruttamento del lavoro e con la ricerca del massimo profitto, là
dove invece la contraddizione, che è immanente al concetto stesso di
Capitale, attesta il continuo approfondimento del rapporto sociale
capitalistico. Riformisticamente, essi rigettano l’ipotesi
rivoluzionaria “classica” come unica via maestra in grado di superare
con un movimento in avanti la contraddizione. La cosa si mostra con
particolare evidenza a proposito del mitico general intellect,
che in Marx ha una pregnanza concettuale potentemente dialettica
(rivoluzionaria), mentre nei teorici di cui sopra esso svolge una
funzione ideologica chiamata a supportare chimerici programmi comunardi
da realizzarsi hic et nunc, nell’ambito stesso del Capitalismo, e intellettualistiche congetture intorno a supposti nuovi soggetti rivoluzionari.
«Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il sapere
sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva immediata, e
quindi le condizioni del processo vitale stesso della società sono
passate sotto il controllo del general intellect, e rimodellate
in conformità ad esso; fino a quale grado le forze produttive sociali
sono prodotte, non solo nella forma del sapere, ma come organi immediati
della prassi sociale, del processo di vita reale» (9). Solo la
Rivoluzione sociale è in grado di rovesciare dialetticamente la Potenza
del Capitale, di assestare un colpo mortale ai vigenti rapporti
sociali, i quali danno corpo a una prassi che rende sempre più
possibile l’emancipazione integrale (materiale e “spirituale”) degli
individui nello stesso momento in cui la nega sempre di nuovo
nel modo più violento. Se non si comprende questo,
1. si rimane
abbagliati dalla strapotenza del Capitale (per reagire alla quale
l’ideologia degli ottimisti della “rivoluzione” offre sempre mille
illusorie vie di fuga concettuali),
2. facilmente si nutrono bizzarre
idee intorno a «questo tempo di algoritmi macchinici»,
3. si cullano
false – ancorché poco allettanti – speranze su «una possibilità per
costruire un sistema monetario e finanziario alternativo, in grado di
superare i nodi contraddittori e iniqui del capitalismo contemporaneo»
(Fumagalli).
Com’è noto, Marx elaborò la sua concezione della moneta partendo
dalla teoria del valore, centrata però non più sul lavoro individuale e
sulla divisione del lavoro nella singola unità produttiva, bensì sul
concetto di lavoro astratto o sociale, il cui sostrato materiale prende
corpo nel mercato attraverso il confronto, mediato dalla transazione
merce-denaro, tra i diversi lavori che hanno concorso alla produzione
delle merci che affollano appunto il mercato. Lungi dall’essere un mero
concetto, il lavoro astratto è in primo luogo un fatto, anzi un processo che sta dentro la reale dialettica della creazione della ricchezza sociale nella sua forma capitalistica. E analogamente è un processo
(sociale) il denaro colto nelle sue diverse e contraddittorie
determinazioni: come misura del valore-lavoro, come mezzo di pagamento,
come mezzo di scambio.
Marx scopre che il denaro, in quanto equivalente generale in grado di
svolgere una fondamentale funzione sociale (l’atto di compra-vendita),
non esprime tanto il valore di ogni particolare lavoro condensato in
una peculiare merce, quanto piuttosto il valore del lavoro colto nella
sua dimensione sociale, ossia come media sociale. Infatti, «In
conseguenza della diversa composizione organica dei capitali impiegati
nei diversi rami di produzione […], capitali di eguale entità mettono in
movimento quantità di lavoro molto diverse, essi si appropriano anche
quantità molto diverse di plusvalore. I saggi del profitto dei vari
rami di produzione sono quindi originariamente molto diversi. La
concorrenza compone questi diversi saggi del profitto in un saggio
generale del profitto che rappresenta la media di essi. Si chiama
profitto medio il profitto che, conformemente a questo saggio generale
del profitto, tocca a un capitale di entità determinata, qualunque sia
la sua composizione organica» (10). È quello che con la consueta ironia
Marx definisce «comunismo capitalistico»: a ogni capitale secondo la
sua grandezza.
Da quanto appena visto deriva il concetto di prezzo di produzione
della merce, che è uguale al suo prezzo di costo più il profitto che
corrisponde appunto al saggio generale del profitto, «che presuppone
d’altra parte che i saggi del profitto, presi in sé in ogni singola
sfera di produzione, siano già stati ridotti ad altrettanti saggi medi»
(11). È dunque il mercato, attraverso la concorrenza che mette a
confronto il contenuto di valore delle diverse merci, e non l’impresa
che pure quel valore ha creato, il luogo in cui la dimensione
contraddittoriamente sociale del Capitalismo si manifesta compiutamente.
Il denaro esprime nella forma più adeguata questa dimensione. «Il
denaro dunque, come valore di scambio di tutte le merci, sta accanto e
al di fuori delle merci stesse» (12): è precisamente in questa doppia
qualità che si radica quella tendenza all’autonomizzazione della sfera
finanziaria che dà luogo a numerose e importanti aporie concettuali da
parte della scienza economica, come a una serie di contraddizioni reali
(una su tutte: la sconfinata brama di profitto e la ristretta, anzi miserabile base materiale su cui esso riposa: il plusvalore estorto ai lavoratori) che la crisi economica puntualmente registra.
Per mutuare il Sismondi citato da Marx, la crisi ha il potere di
rimettere insieme l’ombra e il corpo che la vertiginosa circolazione
finanziaria separa sempre di nuovo. Inutile dire che molti confondono
l’ombra con il corpo che la rende possibile, e seguendola con la bava
alla bocca spesso si mettono sulla strada che conduce al disastro.
Il fatto che, come osserva giustamente Fumagalli, «La sovranità
monetaria (nazionale o sovranazionale, che sia), la cui governance è il
compito della Banca Centrale, perde sempre più significato» conferma a
mio avviso la tendenza storica immanente alla natura del Capitale a suo
tempo colta e spiegata, nei tratti essenziali, da Marx (13).
Salito con grande fatica in cima alla gigantesca montagna concettuale
(o «merda economica» che dir si voglia) che si materializzò sulla sua
metaforica scrivania, il Moro di Treviri capì quanto ingenua fosse
l’idea di eliminare, a rapporti sociali immutati, la moneta in vista di
un segno di valore che registrasse immediatamente ogni individuale
tempo di lavoro «cristallizzato» in ogni singola merce. «Il tempo di
lavoro non può essere esso stesso immediatamente denaro» (14),
nonostante ne realizzi il presupposto sociale: «Questa contraddizione
può essere risolta solo oggettivando la contraddizione stessa». Ma per
oggettivarla, prima bisogna comprenderla, questa contraddizione,
operazione che ad esempio non riuscì a Proudhon, sostenitore di un
capitalismo piccolo-borghese che se visto da Londra già ai suoi tempi
appariva superato e persino ridicolo.
A proposito di modello piccolo-borghese di Capitalismo, eccone forse un saggio: «Una cripto-moneta con le caratteristiche di moneta del comune
può essere introdotta in un sistema economico al fine di remunerazione
del lavoro e di finanziamento degli investimenti a favore della
cooperazione sociale solo se il ciclo di produzione si svolge
all’interno di confini geografici definiti. Da questo punto di vista,
una moneta locale può svolgere questo ruolo. È quindi necessario far
riferimento ad attività economiche che, per loro natura, non sono
globalizzabili: ad esempio, l’erogazione di servizi sociali, come
l’istruzione e la formazione, la gestione dei trasporti e della la
sanità, l’offerta di sicurezza sociale, cultura e tempo libero,
l’attività immobiliare, agricola e la produzione di artigianato locale
insieme a quella parte della produzione manifatturiera la cui filiera
produttiva è tutta interna al territorio preso in considerazione,
potrebbero essere dei buoni esempi iniziali» (Fumagalli). Il
Comun(e)ismo ha tanto l’aria, ai miei occhi per niente attraente, di un
Capitalismo “a misura d’uomo”, a “filiera corta”, “equo e sostenibile”,
insomma un capitalismo a immagine e somiglianza di certi strati
sociali di media e piccola borghesia oggi stressati e declassati dalla
crisi economica.
________________________________________

Nessun commento:
Posta un commento
Di la tua