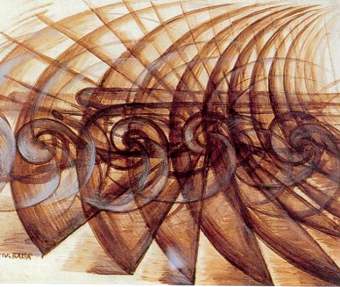 1.
Che l’ideologia e la cultura del postmodernismo – quale cancellazione
della realtà a favore dell’artefatto e dell’immateriale – stia
definitivamente esaurendosi, dopo aver esercitato la sua egemonia per
circa un quarantennio, comincia ad essere percezione diffusa, acquisita
in termini di esperienza emotiva ed esistenziale, prima che riflessa
in consapevolezza critica e teorica.
1.
Che l’ideologia e la cultura del postmodernismo – quale cancellazione
della realtà a favore dell’artefatto e dell’immateriale – stia
definitivamente esaurendosi, dopo aver esercitato la sua egemonia per
circa un quarantennio, comincia ad essere percezione diffusa, acquisita
in termini di esperienza emotiva ed esistenziale, prima che riflessa
in consapevolezza critica e teorica.
I miti della fine della storia e dei conflitti, del valore del
frammento in opposizione alla totalità e al sistema, del primato del
linguaggio e dell’interpretazione, della cancellazione della realtà ad
opera del virtuale, sono crollati ad opera della realtà stessa e della
sua lezione che ha intensificato la modernità del capitalismo nell’ipermodernità
di un capitalismo globale che si propone come unica forma possibile di
vita, pur nella dilatazione a «mondo» delle sue scissure, depredazioni
e contraddizioni.
Nella sua versione ipermoderna, definita da una unificazione dura e
terribile delle condizioni materiali di vita, ma spogliata
dell’ideologia del progresso e di uno sviluppo sostenibile ed
estendibile a tutti che lo accompagnava nella modernità, il capitalismo
palesa oramai il fallimento di un’intera generazione di intellettuali.
Una generazione che ha osannato la raffinatezza dell’immagine e del
virtuale rimuovendo lo svuotamento generalizzato che andava erodendo il
vivere e il sentire degli individui, e preferito civettare con un
«Altro» maiuscolo e metafisicamente inafferrabile piuttosto che indagare
e circoscrivere criticamente quel soggetto impersonale ed altro che è
costituito dall’astrazione del capitale, e che sempre più si affermava
come il vero soggetto esclusivo dell’accadere storico e della totalità
delle nostre esperienze personali.
Con la caduta del Muro di Berlino e del fordismo sovietico e con il
trionfo dell’economia leggera e postfordista, delle nuove tecnologie
informatiche, dell’investimento sempre più forte nel capitale
finanziario, è stato facile, per l’intellettuale, stabilire che il
pensiero non avrebbe potuto essere che ‘debole’, privo di centri e
luoghi di senso gerarchicamente privilegiati. Ogni ricostruzione critica
dei nessi sistemici e totalizzanti di una realtà tendenzialmente
unitaria e globale doveva essere abbandonata in nome della decostruzione
e della moltiplicazione differenzialista, di un’ermeneutica consegnata
al multiversum e alla relativizzazione del senso, alla
polisemia del significante, in un percorso mai concludibile che non solo
si sottraeva ad ogni funzione identificante, ma che con l’identità
lasciava cadere la necessità e la possibilità di scelte di campo e del
conflitto.
Accanto e in opposizione all’intellettualità sofisticata e suntuosa
dei pochi pastori del postmoderno, però, la rivoluzione informatica del
capitale postfordista metteva in campo, come condizione di massa e dei
più, la vera figura dell’intellettuale ipermoderno, condannato a un
sapere non di radicamento e approfondimento ma di superficie, con un
grado minimo e soffuso d’interdisciplinarità, con una destinazione
lavorativa altamente variabile e fungibile, e proprio perciò capace di
interagire con le macchine dell’informazione e interpretare/eseguire
schede e disposizioni di lavoro più o meno formalizzate.
L’adesione dell’intellettualità colta e prevalentemente accademica al mito della grande potenza del linguaggio,
dell’autorefenzialità della sfera comunicativa, della sua assenza di
riferimento a qualsiasi realtà materiale ed extralinguistica, si è
associata, con effetti storico-sociali assai maggiori, allo sviluppo di
una forza-lavoro intellettuale e di massa, pronta a subire in modo
passivo il rovescio di quel mito, ossia l’asservimento della propria
mente ai programmi e ai comandi di lavoro depositati nella memoria
artificiale ed alfa-numerica della macchina dell’informazione.
E non è un caso che in Italia questa concordia di opposti tra
intellettualità dei pochi e intellettualità dei molti, volta alla
produzione del nuovo lavoratore della conoscenza, si è concretizzata in
una invereconda riforma dell’Università che, con l’appoggio se non con
l’entusiasmo di buona parte dei docenti universitari, ha sottratto,
soprattutto alla cultura umanistica, ogni profondità e coerenza di
formazione, per dar luogo ad una mente ‘liquida e debole’, fatta di una
congerie di nozioni, incapace di una interiorizzazione soggettiva
dell’esperire, e pronta proprio per questo a dialogare in modo acritico e
spersonalizzato con la tecnologia dell’informazione.
2. Restituendo in modo drammatico pregnanza e valore alla durezza della realtà materiale, all’esasperazione e alla crisi dell’economico, oggi l’ipermodernità esautora l’ideologia postmodernista e ci esorta a considerare la produzione di linguaggio non più nella sua autonomia bensì come intrinsecamente connessa ad altre produzioni di socialità e ai loro statuti, non strutturati e ordinati linguisticamente.
Noi – e questo è il progetto culturale più proprio di «Consecutio
temporum» – non vogliamo tornare al moderno. Non solo perché ciò sarebbe
impossibile. Ma anche e soprattutto perché del postmoderno intendiamo
accogliere tutto quanto ha esplorato e ci ha insegnato di nuovo e di
prezioso: nel verso di una complicanza e arricchimento di prospettive,
di innovamento di categorie interpretative, di messa in rilievo di nuove
modalità della relazione umana, sia dal lato intersoggettivo che da
quello intrapsichico ed emozionale. Vogliamo accogliere cioè tutto
quanto il postmodernismo e il pensiero debole ci ha consegnato nella
direzione di una nuova delineazione dell’umano, emancipata da quella
bisognosità meramente materiale e da quell’antropologia della penuria in
cui troppo spesso l’aveva confinata la cultura del moderno, con la sua
predilezione per i grandi aggregati e una teoria della relazione
fondamentalmente esaurita nella lotta e nella contraddizione delle
classi.
Pur nell’estremizzazione e nella forzatura della sua argomentazione
di fondo sulla morte del soggetto, il postmodernismo costituisce un
valido antidoto contro le facili presupposizioni mitologiche della
vecchia antropologia marxista, col suo materialismo semplicistico e
fusionale, l’autocelebrazione e autorassicurazione dell’umano, la sua
propensione a proiettare solo nell’esteriorità del nemico ogni pulsione
negativa e distruttiva armata. Un antidoto per non tornare a una
soggettività troppo ingenuamente presupposta e troppo semplicisticamente
delineata nel suo facile transito, senza problema alcuno,
dall’individuale al collettivo e dal pubblico al privato, quasi che la
comunanza materiale ed economica –l’identità di classe, appunto–
bastasse a risolvere in sé tutti i motivi e i temi di vita
dell’individualità umana; quasi che i rapporti sociali −come ha suonato e
preteso la celebre sesta tesi marxiana su Feuerbach , e a partire di
lì tutta l’antropologia del marxismo storicistico, inclusa l’opera
nobile di Antonio Gramsci− esaurissero veramente e fino in fondo
l’esistenza dell’essere umano.
Dopo il tempo della liquidità e della moltiplicazione di piani, è
giunto il tempo di tornare a valorizzare la funzione della sintesi,
proprio perché a diventare sempre più sintetica è la capacità
dell’economico di penetrare e pervadere ogni residuo spazio di vita,
sostituire il rapporto quantificato e mediato dal denaro ad ogni altro
tipo di relazione, dilatarsi e farsi mondo unificando l’intero genere
umano a macchia di leopardo attraverso la violenza delle sue
polarizzazioni.
Riproporre il valore della sintesi, sia per la vita del soggetto
individuale che per il possibile ed auspicabile formarsi di una
soggettività collettiva, implica però una capacità, teoretica e pratica,
di stringere insieme identità e differenza, relazione con il proprio
sé e relazione con l’altro di sé, conoscere e sentire, pensiero
logico-discorsivo ed esistenzialità prelogica ed emozionale.
3. Prima di cadere nella reificazione del linguaggio −nella ipostatizzazione della Negazione/Nulla− e dar luogo a una Scienza della logica metafisicizzata, Hegel aveva argomentato che il bisogno della filosofia nasce dalle scissioni e dalle contraddizioni della vita individuale e collettiva, e quindi dalle passioni e dai tormenti della storia. E che la riunificazione di queste scissure –ossia la produzione di quello che definì l’Assoluto– deve compiersi secondo le movenze e le vicende interiori di ciascuno degli opposti, che nella separatezza ostile e nell’esclusione dell’altro da sé non possono far altro che precipitare in una vita patologicamente sofferta ed esposta alla dissipazione della cattiva infinità. Dunque senza presupporre Assoluti e Fondamenti originari, che costringano la storia degli esseri umani nella gabbia di una filosofia della storia, ma appunto mettendo in campo una filosofia dell’unificazione che muova dall’intrinsecità degli opposti medesimi e non dalla violenza sintetica ed unificante di un Terzo. E che quell’unificazione può procedere, senza violenza né dominio dell’uno sull’altro o di un terzo unificatore, solo attraverso una quadruplicazione dei termini opposti, e a condizione che ciascuno dei due si faccia l’intero, riconoscendo che l’altro, anziché esterno ed opposto, è invece intrinseco e parte costitutiva della propria identità.
Per dire cioè che nello Hegel di Francoforte e di Jena è emersa, poi
non sufficientemente sviluppata, una teoria dell’emancipazione che
riusciva a vedere nelle pratiche complesse del ‘riconoscimento’
un’ipotesi di fuoriuscita dal nesso Rivoluzione francese-Terrore, ossia
dal nesso pratica rivoluzionaria-azione violenta.
Per questa motivazione di fondo, di un processo di trasformazione
storica senza violenza, «Consecutio temporum» continua a dedicare anche
il suo numero quattro alla tematica del riconoscimento.
Il rilievo che questo paradigma, antropologico, sociale ed
etico-politico, continua ad occupare in un modo che sembra ormai
permanente nel dibattito attuale delle scienze umane, come l’abbondanza
del materiale che è giunto alla nostra redazione, ci hanno esortato
alla pubblicazione di un altro numero dedicato alla stessa tematica del
precedente.
Abbiamo già indicato nel numero precedente (cfr. l’editoriale del
numero 3) quanto la tematica del riconoscimento, sopratutto nell’ambito
della tradizione del marxismo e della teoria critica della Scuola di
Francoforte, abbia costituito l’esito di una necessità improrogabile di
cambiamento di paradigma teorico. Di fronte all’antropologia della
bisognosità solo materiale su cui si era fondata la filosofia sociale e
politica del marxismo era infatti divenuto imprescindibile rivendicare
la centralità nella costituzione del soggetto umano non solo dei
bisogni corporei-materiali, ma anche di un desiderio di riconoscimento
della più propria individualità che valesse per ciascuno a favorire e a
garantire un’individuazione irriducibile ad ogni misura comune. Così
l’etica del riconoscimento è nata, almeno in ambito francofortese, prima
con Habermas e poi e sopratutto con Axel Honneth proprio per far
uscire la tradizione del marxismo e del pensiero critico da
un’antropologia arcaica, incapace di mettere a fuoco la determinazione
relazionale del desiderio di essere riconosciuti, accolti e valorizzati
nella più propria e irrepetibile individualità di esistenza. Un
bisogno/desiderio, la cui rimozione, generata dalla miopia dello
sguardo di Feuerbach e del giovane Marx verso l’icona hegeliana,
avrebbe generato molte delle rigidità e dei disastri del marxismo
teorico.
Affermare la legittimità e la centralità del desiderio di
riconoscimento accanto all’istanza corporea e materialistica del bisogno
non può significare però, per «Consecutio temporum», assentire alla
radicalità di quel dualismo tra bisogno e desiderio la lezione di Kojève
ha estratto dalla Fenomenologia di Hegel, e di lì ha
consegnato a buona parte della cultura francese e contemporanea. Perché
non ci è mai sembrato fecondo operare nell’ambito dell’antropologia
filosofica e delle scienze umane in generale con quella distinzione cosi
rigida tra desiderio di sé e desiderio dell’altro, tra corpo e mente,
tra natura e cultura, tra individualità biologica e identità sociale,
tra finito e infinito che il pensatore russo-francese ha tratto dalle
pagine hegeliane dell’autocoscienza, con una lettura poco meditata e
poco mediata alla luce delle altre sezioni dell’opera, in particolare di
quelle argomentazioni che precedono e fondano la concettualizzazione
della vita come infinita.
Da quella dicotomia kojeviana, che traeva ispirazione dalla guerra mossa dalla differenza ontologica di Heidegger contro la dialettica di
Hegel e di Marx, sono derivate molte cose e molti pensieri, tutti
iscritti in una comune diffusione e dilatazione del paradigma dualista:
inconscio contro conscio, differenza contro identità, frammento contro
totalità, evento contro storia. Fino a giungere a quella scissione
lacaniana tra godimento e desiderio, tra soddisfazione del corpo ed
esposizione all’Altro, che, oltre a richiudere il cerchio con
l’iniziazione heideggeriana dell’ex-sistenza come relazione
all’assolutamente Altro dell’Essere, sembra riproporre la spiritualità
romantica della nostalgia e della ricerca infinita di un oggetto
eternamente sfuggente e del permanente stato d’insoddisfazione che ne
deriva.
Per «Consecutio temporum», invece, l’unica via proponibile appare
essere quella, dialettica, della mediazione e del superamento dei
dualismi e delle scissioni. In un recupero di tutti i piani nuovi ed
originali che la cultura del Novecento, nelle sue diversissime voci, ha
scoperto e indagato, ma appunto ricondotti ad un piano sistematico
d’integrazione, in cui il riconoscimento attivo e passivo −e la trama
dei vari istituti e modi della relazione che esso implica− non
significhi denegazione od omologazione di un sé individuale, bensì la
sua valorizzazione, nel perseguimento del suo più proprio progetto di
vita, proprio attraverso la mediazione e la facilitazione messa in atto
da un intero ambito antropologico-culturale e sociale.

Nessun commento:
Posta un commento
Di la tua